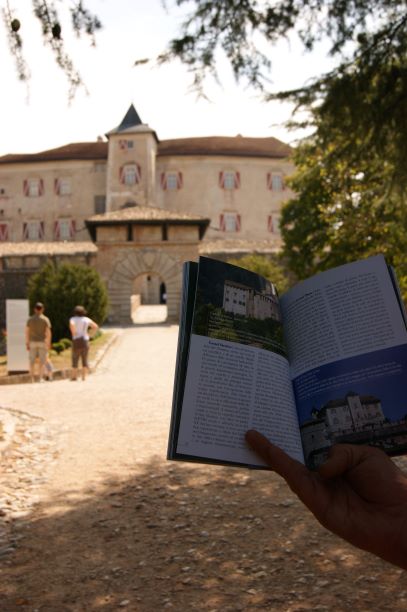L’angolo delle riflessioni
Italia surreale (Stridone, 17 gennaio 2022)
Dal mio ritiro istriano, senza canali televisivi e con un solo cellulare che fa fatica a trovare rete, scrivo questa riflessione al computer (il portatile viaggia sempre con me, dovessi andare anche al Polo Nord) che pubblicherò una volta ritornata in città. Ho osservato a lungo una foto scattata a Roma da un mio caro amico, lo scorso sabato. C’era un sole quasi primaverile, il cielo terso e un clima piacevole. Nella zona di piazza Venezia, con l’imponente Altare della Patria sullo sfondo, la visione delle strade deserte e di neanche un turista a spasso, mi ha messo una tale tristezza ed una rabbia difficili da descrivere. Nel suo racconto ci sono molti altri dettagli, alquanto inquietanti; l’autostrada da Trieste a Roma semideserta, gli autogrill vuoti e la capitale spettrale, come vittima di un maleficio. I ristoranti totalmente vuoti, non con qualche cliente, ma vuoti, idem i bar, con al massimo lo sporadico avventore che consuma in fretta e se ne va. I monumenti della città eterna soli e abbandonati, neanche l’ombra di un turista, le strade solitamente caotiche, vuote, e i mezzi pubblici disertati, questo in una giornata di tempo libero, con i saldi in tutti i negozi. Ecco com’è ridotta l’Italia dopo due anni di pandemia, di follia collettiva: land of paranoia, come la chiamo ormai abitualmente. Non ci sono piani B, non ci sono soluzioni, la “cabina di regia” che proroga continuamente lo stato d’emergenza non prova empatia per il popolo massacrato dall’economia sbriciolata, dal costo della vita sempre più insostenibile e dalla crisi energetica che ci farà collassare, colare a picco. Dalla scrivania della mia stanza, con la vista sui muretti a secco e gli alberi spogli, le montagne avvolte nel crepuscolo e la pallida luna che si staglia nel cielo, non posso che riflettere su come sono stati per me questi ultimi due anni.
Mi sono ammalata di covid a inizio pandemia, anzi, quando ancora non si sapeva esattamente cosa sarebbe accaduto. Era la fine di febbraio del 2020; si iniziava a parlare di Codogno, della Lombardia e di Bergamo in particolare. Ricordo che ero sull’autobus, verso la metà del mese, eravamo stipati come sardine, e mi son detta: qua dovesse esserci il virus cinese, ci ammaliamo tutti. Pochi giorni dopo ho iniziato ad avere i primi sintomi e purtroppo ho passato la malattia anche alla mia anziana madre. Non capivo, non comprendevo, solo dopo tanto tempo ho saputo che il virus circolava in Italia da parecchio, dato che molte ditte edili di Bergamo lavoravano a Wuhan per la costruzione di un grande centro commerciale (vi invito a verificare l’informazione, troverete un articolo del Sole) e poi perché nell’era della globalizzazione non c’è blocco o frontiera che regga alla diffusione di una malattia. No, non era un’influenza, stavo dannatamente male; il respiro affannoso, il dolore al petto, la bronchite acuta, e poi l’otite, la congiuntivite, la laringite, le tonsille ricoperte di placche e nessun rimedio valido. Stare sdraiata mi faceva andare in apnea, mi sembrava di soffocare. Poi la preoccupazione e il rimorso per aver contagiato mia madre, finita al pronto soccorso. Era il panico, in ospedale non sapevano che fare; non facevano ancora i tamponi a tutti, si limitavano a controllare l’ossigeno nel sangue e ti rispedivano a casa. L’abbiamo scampata entrambe, dopo due settimane di supplizio e con qualche conseguenza fisica nei mesi successivi. Poi l’Italia ha chiuso, tutti a casa, isolati. Guardavo dal terrazzo la tangenziale che si snoda a breve distanza, completamente vuota; nessuno poteva uscire, nessuno si faceva vedere, soltanto le gru del porto muovevano le merci e vedevo entrare nel golfo le petroliere con i carburanti. Sono stati mesi devastanti sul piano fisico e psicologico, ed io ho fatto un madornale errore che avete fatto anche voi: ho guardato la televisione italiana ed ho ascoltato i virologi diventati improvvisamente star del piccolo schermo. Gli ultimi tra i medici, quelli solitamente ignorati a vantaggio dei grandi chirurghi, degli oncologi e dei professionisti delle varie specialità mediche, ora erano gli oracoli davanti ai quali tutti ci inchinavamo. Un’angoscia simile io credo di non averla mai provata, tra bollettini di guerra e martellamento incessante in tutte le possibili trasmissioni televisive, fino ad arrivare alla pubblicità: era un continuo terrorizzare la gente. Poi ricordo di aver visto un uomo passeggiare in riva al mare, da solo, inseguito dagli elicotteri e dai droni, catturato dalla polizia e condotto via. Ecco, lì ho capito che dovevo spegnere la televisione e fare una riflessione. La conclusione è stata che vivevo in una nazione di pazzi ipocondriaci, terrorizzati dalla malattia infettiva che ha colpito duramente l’Italia ma beatamente incuranti dello spaventoso numero di morti per cancro, tanto per dirne una, perché non è contagioso, allora anche se se lo piglia mio cognato o mia suocera, crepano loro, mica io! In una società del genere ero io che dovevo starmene per conto mio, scrivere un nuovo libro (cosa che ho fatto) e attendere questo benedetto vaccino che promettevano sarebbe stato la nostra salvezza. Ed è arrivato il vaccino, dopo un inverno atroce, un Natale in zona rossa, una Pasqua in zona rossa, un’Italia di imprenditori e commercianti alla canna del gas che chiedevano di poter lavorare per sopravvivere e una primavera di mascherine sempre sulla faccia, anche per portare a pisciare il cane alle undici di sera. Non c’erano più i ridicoli striscioni andrà tutto bene, nessuno la pronunciava più quella frase e nessuno cantava sui balconi: le strofe erano belle che esaurite. Appena giunto il mio turno sono andata a vaccinarmi, due belle dosi, mettendomi in fila, riempiendo moduli di “consenso”. Mi sono sentita debole per settimane, mi trascinavo in giro per la casa, non sopportavo di stare al sole ed ero spossata. Poi è arrivato l’autunno e le mie difese immunitarie, temprate nella casa d’Istria senza riscaldamento e con 0 gradi in camera da letto, quand’ero piccola, con anticorpi delle dimensioni di uno hobbit, sono andate tutte a farsi friggere; per anni non ho avuto un’influenza, mentre da settembre a novembre mi sono ammalata ben tre volte, tra le quali una forma intestinale che mi ha quasi ammazzato (cinque chili persi in due giorni, l’unico liquido che ancora avevo in corpo era il sangue), infinitamente peggiore del covid sperimentato. Non so a cosa sia dovuto, forse tutto quel tempo chiusi in casa, sempre con le mascherine che non ti fanno respirare l’aria liberamente e senti gli acidi corroderti lo smalto dentale, tant’è che peggio di così non potevo stare. E poi, dopo aver detto tutto e il contrario di tutto, dopo aver promesso miracoli sierologici ed aver definito i non vaccinati sorci chiusi in casa, dopo aver imposto il green pass anche per andare al cesso, ecco la novità: il vaccino ha una scadenza, un po’ come il latte a lunga conservazione, e dopo nove mesi bisogna rifarlo, non dopo un anno che era troppo ottimistico, eh! Anzi no, dopo sei mesi. Anzi no, dopo quattro; insomma, ci vuole la booster signori, non son caa-voli che tengano, ci vuole la booster! Ed io mi incazzo, mi incazzo forte, ho voglia di mollare un ceffone a qualcuno. Perché in Italia tu non puoi porti delle domande, non puoi avere dei dubbi, non benefici del lusso di una critica, poiché se osi fare ciò sei un no-vax rivoltante, un ignorante che non rispetta la scienza, un criminale da multare e possibilmente da mettere al muro quale nemico del popolo. Se non sei un medico non devi parlare e non ti devi opporre al trattamento sanitario, perché mica il corpo è tuo, e se invece sei un medico che la vede diversamente, allora bisogna radiarti, umiliarti in pubblico e tentare di portarti al suicidio. E su la mascherina, senza il naso fuori o chiamiamo la polizia, la Digos e l’FBI; la ffp2 sui mezzi pubblici, ma anche nei luoghi chiusi e meglio ancora anche in quelli aperti, quando si è con i parenti o con l’amante, perché, chissà cosa combina quella quando non è con te. Intanto in Italia, con quasi il novanta per cento di vaccinati, viaggiamo sui 400 morti al giorno.
Non ne potevo più, sentivo l’esaurimento nervoso arrivare, allora ho fatto una valigia con poche cose, ho preso gli animali ed eccomi qui, nella casa di pietra antica, per fortuna ora riscaldata. Mi sento libera, respiro l’aria a pieni polmoni e me ne vado in giro a Pinguente senza stracci sulla bocca, senza paranoie; la gente sembra serena, qualcuno persino sorride, e in questo anomalo gennaio i bar con i tavolini all’aperto sono pieni all’ora dell’aperitivo. Non raccolgono i morti per strada, anche senza avere il 90 per cento di vaccinati, vivono la vita nel miglior modo possibile e con le logiche regole di prevenzione: nessuno al supermercato ha la mascherina calata, nessuno. Poi mi arriva la telefonata di mio fratello; vaccinato lui, vaccinata la sua compagna, entrambi positivi al covid e con sintomi, infettano pure i bambini che però stanno benone. Tutto sommato sono contenta per loro, dopo tre giorni si sentono discretamente bene e quella meravigliosa, fantastica, sublime, magica, miracolosa, spettacolare dose booster non se la devono fare. Io invece me la inoculo venerdì, e penso alle parole del viceministro Sileri, la variante omicron raggiungerà tutti e quelle dell’OMS, occorrono nuovi vaccini perché questi sono poco efficaci con le varianti. Ed ho una gran voglia di mollare ceffoni a destra e a manca, ma così tanta da slogarmi il polso. A marzo dovrò tornare necessariamente in Istria, se preferisco non impazzire.
Il fronte del porto (Trieste, 18 ottobre 2021)
Non ero abituata a vedere certe scene di protesta e scontro nella mia città, Trieste, dove l’autocontrollo e le regole hanno ancora un senso. Il fronte del porto, questa mattina, rimanda immagini di idranti sparati dalla polizia sulla folla di manifestanti che presidiano il varco 4 ma non lo bloccano. Una manifestazione inizialmente non violenta e seguita dalle emittenti di tutta Italia che viene stroncata dal poliziotto con la frase stucchevole in nome della legge. Camionette della polizia, violenti getti d’acqua, agenti in tuta antisommossa, lacrimogeni, gente urlante; una bolgia infernale in una mite giornata di ottobre senza bora e con il sole, a poche centinaia di metri dal luogo in cui scrivo. Mi tremano le mani mentre guardo le immagini, le voci di uomini e donne che inneggiano alla libertà nei fumi del gas, sulla strada che percorro quasi quotidianamente. Sotto il cavalcavia gli agenti si posizionano a testuggine, mostrano i manganelli e tirano altri lacrimogeni, la gente indietreggia e rilancia, qualcuno si avvicina, cerca di parlare ma viene spinto via. Nessuna trattativa, nessun gesto di distensione, da lì i manifestanti se ne devono andare. Viale Campi Elisi è irriconoscibile, tra gli idranti, la gente che urla scomposta, l’avanzata della polizia. I manifestanti no green pass sono stati separati dai lavoratori del porto, da coloro che hanno iniziato e animato la protesta, chiedendo che venisse garantito a tutti il posto di lavoro e il salario. Dal viale la gente inizia a disperdersi, porta la protesta nelle altre strade della città, bloccando la viabilità e avvicinandosi ai palazzi delle assicurazioni e della cantieristica. Gli alberghi pieni di questi giorni hanno anticipato l’imponenza della manifestazione che vede la partecipazione di tante persone, da varie parti d’Italia, giunte nella città diventata il simbolo della protesta. Attonita e amareggiata, provo un profondo dispiacere per i lavoratori del porto che ci hanno garantito il gas, i carburanti e tutte i generi di cui avevamo bisogno nei lunghi mesi di chiusura. Li vedevo lavorare dal terrazzo di casa, tra gru e cavalieri, carrelli e duro lavoro manuale, di giorno e di notte, per garantirci il cibo nei frigoriferi e la benzina nei serbatoi. Mentre Stefano Puzzer, leader dei portuali, raccontava le loro ragioni agli intervistatori, negli studi televisivi giornalisti prezzolati e presentatrici col botulino esploso in faccia sghignazzavano per l’accento e la terminologia usate. Ho provato un tale disgusto verso i mass media, verso i lecchini del potente di turno con i contratti da difendere che spegnere il televisore mi è sembrato poco, ho avuto voglia di gettarlo dalla finestra e di ignorare tutte le notizie on line dei cosiddetti “professionisti dell’informazione”.
Non so come finirà questa manifestazione, ne scriverò ancora, di fatto stamattina stiamo vedendo la polizia caricare manifestanti senza bandiere politiche, diverse persone anziane e inermi, in una giornata di urne aperte e con il porto assolutamente operativo. Se questa è la democrazia, devo aver capito decisamente male.
La disfatta dell’Occidente (Trieste, 21 agosto 2021)
Le catastrofiche immagini che giungono dall’Afghanistan, oltre a sbalordirmi, mi hanno evocato un ricordo. Era il 1989, un anno fatidico nella mia vita. Nella cucina di casa nostra, in Istria, guardavo la televisione assieme a mio padre. Le immagini erano impressionanti, le truppe sovietiche che avevano occupato l’Afghanistan nel 1979 si stavano ritirando; i mezzi carichi di uomini imbronciati e sprezzanti, lasciavano il desertico suolo ai mujaheddin che li avevano presi a calci negli stinchi. Dissi a mio padre: “Lo vedi papà? Se ne vanno con la coda tra le gambe come gli americani dal Vietnam. Un piccolo popolo batte nuovamente una grande potenza”.
Mio padre mi guardò con occhi orgogliosi, poiché a differenza di molte ragazzine sciocche della mia età, mi interessavo di politica internazionale, come lui mi aveva insegnato. Era anche uno sguardo pieno di indulgenza verso una sedicenne che dei grandi giochi politici non aveva ancora capito niente.
“Piccola mia”, fece ad un certo punto, “non credere che possa finire così. Quella parte di mondo è sempre in subbuglio ed è importante per le grandi potenze, perché da lì controllano l’Asia”.
Pensai che mio padre fosse ormai anziano (quanto sono crudeli i giovani!), privo di sogni e con pochi ideali, in quell’Istria povera e sottomessa alla Jugoslavia. Dopo neanche dieci anni e attraverso una guerra civile sanguinosa, i talebani presero il potere in tutta la nazione e appesero alle porte di Kabul il presidente Ahmadzai. Seguirono anni di terrore e morte, di donne lapidate allo stadio, di burka, di indicibili violenze sui bambini. Ero ormai cresciuta ma non ancora disposta a credere a mio padre. Con un’associazione femminista mi misi a raccogliere firme per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione femminile in Afghanistan, in una fase della vita in cui si pensa di cambiare il mondo raccogliendo delle firme. Poi, all’alba del ventunesimo secolo, i due giganteschi Buddha che sorvegliavano l’antica via della seta, saltarono in aria nell’indifferenza del mondo intero; pochi mesi dopo crollarono le Torri Gemelle, mostrando a quello stesso mondo la furia dell’islam radicalizzato. Oramai ero una donna e ammisi che mio padre aveva ragione. In quegli stessi giorni il leggendario comandante Massoud, il leone del Panshir, fu assassinato da due terroristi spacciatisi per giornalisti, in un attentato suicida. Due giorni prima delle Torri, il 9 settembre, come se tutto fosse previsto da un disegno ben congeniato. Il grande comandante aveva combattuto i sovietici e poi i talebani, rendendo la valle del Panshir l’ultimo bastione di difesa contro gli islamisti. Seguivo ammirata le sue gesta negli anni ’90, quando gli studenti coranici non riuscirono ad espugnare la regione resa da Massoud una fortezza impenetrabile, sfruttando la particolare morfologia del territorio. Il leone chiese e anche ottenne aiuto dall’Occidente nella sua solitaria battaglia ma mai si fidò, consapevole dell’ipocrisia e del doppiogiochismo che caratterizza la nostra civiltà. La prima conseguenza degli attentati in America fu l’invasione dell’Afghanistan, voluta da tutti e da tutti gli americani pretesa per catturare Bin Laden (non c’erano bandiere della pace in quel frangente, solo il desiderio di vendetta di un popolo altezzoso che si è visto violare dentro casa). La missione fu organizzata male, realizzata peggio e terminata, dopo 20 anni, in una delle peggiori sconfitte della storia occidentale. Anche l’invasione dell’Iraq fu un insuccesso colossale che diede vita all’Isis dopo la disastrosa ritirata, ma l’abbandono di Kabul di questi giorni, fatto in fretta e furia con il caos all’aeroporto e gli elicotteri in fuga, sembra la brutta copia di Saigon nel 1975. Il discorso del vecchio, stantio, fiacco presidente Biden ad una nazione umiliata nel suo guerresco orgoglio, rappresenta il fiasco totale del nostro sistema di vita sulle rampanti nazioni orientali che sghignazzano di gusto. In tutto e per tutto l’America appare sconfitta, senza possibilità d’interpretazione; un vecchio gigante barcollante come il suo presidente che inciampa, appare confuso, sbaglia a leggere i discorsi e si accompagna alla first lady muta, attempata e con le mascherine in tinta. L’esatto opposto del presidente Xi Jinping che saluta dall’alto di un blindato, sorridente, con i capelli impomatati e accompagnato dall’affascinante moglie, la cantante lirica e militare di carriera Peng Liyuan; la bella signora, in visita con il marito in Italia, si era alzata per applaudire la bravura di Andrea Bocelli, mentre politici e imprenditori italiani si inginocchiavano al dragone asiatico come dei “gonzi alla corte degli imperatori della dinastia dei Ming”, avrebbe detto il compianto Franco Battiato. In effetti la Cina non ha di che lamentarsi, ormai è l’unica potenza mondiale rimasta – poiché la Russia di Putin è una nazione gregaria – e con la sua politica limitata agli affari e mai all’intromissione nelle faccende nazionali altrui, si sta aggiudicando il primato assoluto in politica internazionale. La questione dell’Afghanistan, anche in questo senso, è esemplare. Un paese dalla superficie arida e inospitale nasconde sotto la sabbia e le montagne di roccia tesori immensi. I russi lo avevano intuito già negli anni ’80, si erano accorti, facendo dei rilievi, della quantità di gas e di petrolio nel sottosuolo. L’URSS aveva compreso che chi controlla una così vasta zona strategica per l’energia, acquisisce un’importanza enorme in Asia. Infatti, dovessero fare per davvero la condotta Tapi, che dall’India arriva in Turkmenistan, passando da Pakistan e Afghanistan per 1800 km (attraversando Herat, Kandahar, Quetta, Multar), la gigantesca opera trasporterebbe qualcosa come 33 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno. Insomma, quella moderna via della seta di cui tutti parlano e che in Afghanistan era segnata dai due Buddha. Tuttavia, le infinite chiacchiere sulla svolta “verde” dell’economia e della vita occidentale, farebbe sì che la Tapi fosse inutile, in caso di transizione ecologica, quindi l’impegno in Afghanistan non necessario. Salvo però un dettaglio ahimè non trascurabile: nel sottosuolo dell’Afghanistan ci sono molte altre risorse. Depositi di bauxite, rame, ferro, pietre preziose ma soprattutto di litio e terre rare. Il litio, quell’elemento della tavola periodica che figura tra le trenta materie prime per l’indipendenza energetica della UE e le terre rare (neodimio, praseodimio, disprosio) cruciali per la fabbricazione dei magneti dell’eolico, delle auto elettriche, dei pannelli solari e di tutti i microprocessori di ogni dannato cellulare che ci rincoglionisce dalla mattina alla sera. A cosa arriviamo con tutto ciò? Alla Cina, ovviamente, che già fornisce l’80% di terre rare nel mondo e ora, grazie al suo lento lavoro diplomatico, ha anche l’Afghanistan da sfruttare, creando un disequilibrio enorme tra l’America che produce la tecnologia e l’Oriente che la tiene per gli attributi con le materie prime. Gli USA e la UE in pratica dipendono fino al 98% dalla Cina per la fornitura di terre rare (sia proprie che di altra provenienza), essenziali anche per le batterie al litio di ogni pala eolica e di ogni pannello solare. In tutto ciò, naturalmente vi è la beffa, poiché sono stati gli americani con gli analisti dell’U.S. Geological Survey a scoprire per mezzo di sofisticati strumenti 1,4 milioni di tonnellate di terre rare nel sottosuolo afghano, per poi andarsene come dei ladri senza bottino. Non manca nemmeno l’ipocrisia, tratto distintivo dell’Occidente: per estrarre le terre rare occorre attivare un processo altamente inquinante; quindi, si lascia questo lavoro “sporco” alla Cina che a sensibilità ambientale (e non solo a quella) risulta poco avvezza. Da un lato si vuole la rivoluzione verde, dall’altro si lascia ad altri l’impegno nelle miniere e nelle fonderie per ottenere gli elementi essenziali dei microprocessori che tutto controllano. Il disegno degli USA ormai è chiaro: non esiste alcun disegno, nessuna strategia, il vuoto pneumatico. Dai tempi della Korea non hanno fatto altro che combinar casini, invadere e poi andarsene a mani vuote ma con tanti morti sulla coscienza. Con l’Afghanistan, però, hanno superato ogni limite e perso completamente la poca credibilità in politica estera che ancora avevano. In questo paese arretrato e arido ma ricchissimo di materie prime essenziali, hanno voluto portare lo stile di vita liberale e l’hanno proposto alle tribù desertiche che non sanno cosa significhino concetti come la democrazia, i diritti delle donne, il voto, il laicismo. Nelle campagne afghane le donne hanno continuato a portare il burka, ad essere sottomesse all’uomo, ad accettare l’analfabetismo; nelle città come Kabul, invece, si è venduta un’illusione che adesso le donne pagheranno con la vita nel migliore dei casi, o con la schiavitù sessuale negli altri. Donne che hanno studiato e si sono impegnate nelle professioni, in politica, nella vita civile e culturale, abbandonate senza pietà e senza compassione nelle mani dei talebani. Loro, i talebani, lo hanno sempre sostenuto: “voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo”. Infatti, hanno atteso, si sono macchiati le mani col sangue negli attentati, hanno capito che i miliardi spesi per addestrare e armare l’esercito regolare erano sprecati – l’armata di cartone afghana si è dissolta come neve al sole – e nella loro trionfale e indisturbata marcia verso Kabul si sono presi carri armati ed elicotteri abbandonati.
Tornando al mio ricordo iniziale, non mi resta che fare una riflessione; oramai i miei occhi (bisognosi degli occhiali per scrivere e leggere) guardano il mondo in un altro modo e se mio padre fosse ancora con me, gli direi che aveva dannatamente ragione. Il disincanto e il realismo di una donna di quasi cinquant’anni che passa la vita a leggere e informarsi, per scrivere ma anche e soprattutto per capire, ha pochi motivi per ammirare qualcosa o qualcuno nella fogna di menzogne in cui viviamo. Guardando all’Afghanistan, però, qualcosa lo trovo e mi sento per qualche secondo la sedicenne che credeva si potesse cambiare il mondo. Alla televisione ho rivisto Massoud, o meglio la sua copia esatta, vent’anni dopo la morte. Il figlio maggiore non è solo il suo ritratto vivente ma è anche un fiero condottiero tagiko, capace di assumersi il compito di seguire le orme del padre. Il paradosso in questo caso è il fratello minore che ha preso parte ai negoziati di Doha, voluti da Donald Trump, negoziati che hanno spianato la strada all’avanzata talebana in tutto il paese. Dalla Francia il giovane Massoud invita il Panshir alla rivolta e la sua gente risponde con fierezza. Parte delle truppe dell’esercito regolare sono già confluite in quella regione e le milizie locali, armate e addestrate alla guerra da sempre, si preparano per l’ennesima resistenza.
Under Siege (Trieste, 07 gennaio 2021)
Chiunque abbia studiato con profitto Storia, sia nell’itinerario scolastico che per interesse personale, sa quanto le società umane abbiano percorso tortuosi sentieri caratterizzati da conflitti, rivolte e insurrezioni. La storia contemporanea, poi, ci racconta di rivoluzioni brutali che hanno cambiato l’ordine costituito di molti Paesi. In questo contesto si inserisce anche la storia americana, anzi, direi che ne è l’esempio più calzante. Chi è arrugginito in materia storica statunitense forse non ricorda bene le date, quindi rammento che la Guerra d’Indipendenza (1775 – 1783) ha preceduto la tanto decantata Rivoluzione francese ed è stata una ribellione indipendentistica contro lo Stato, ovvero il Regno d’Inghilterra. Già nel 1774 gli americani istituirono il primo Congresso continentale per rendere chiara la visione che avevano del futuro coloniale. La storia americana che vede nel mito della frontiera la sua evoluzione e anche il suo limite, assiste allo scontrarsi delle diverse mentalità che compongono la società nella Guerra di Secessione (1861 – 1865). Dalla lettura di Margaret Mitchell, autrice di Via col vento, il mio interesse per i temi che hanno diviso il Sud dal Nord si è intensificato; l’autrice racconta un mondo finito e la sua ideale bellezza, senza tralasciare la vergogna della schiavitù legalizzata, ma soprattutto fa comprendere al lettore (specie al non americano) i meccanismi di formazione delle forze politiche attraverso un rovesciamento dei valori. Il Partito Democratico nell’Ottocento difendeva gli interessi dei proprietari terrieri del Sud con lo slogan: “Sudisti, secessionisti, schiavisti”. Soltanto il Partito Repubblicano di Lincoln ebbe il coraggio di opporsi a tale approccio e cambiare le cose attraverso l’immenso sacrificio di una guerra civile. Gli anni sono passati, poi sono passati i secoli, ma la grande potenza americana appare ancora divisa. Ciò che si è visto ieri ha lasciato tutti piuttosto perplessi, l’invasione da parte dei manifestati di Capitol Hill, neanche fosse il Nicaragua! Eppure, di rivoltosi negli ultimi mesi se ne sono visti parecchi ma appartenevano alla parte opposta che, nella narrazione liberal e “politicamente corretta”, erano quasi da santificare. Sono stati mesi di rivolte, incendi, negozi devastati e saccheggiati, statue abbattute e violenze incendiarie dei Black Lives Matter e degli Antifa. Queste violenze non erano meno eversive, dato che hanno preso di mira municipi, stazioni di polizia, edifici federali come a Portland. Le statue dei generali confederati sono venute giù, Cristoforo Colombo è diventato l’oggetto privilegiato della rabbia e le autorità politiche – sindaci e governatori Democratici – tutto hanno tollerato. Alla polizia fu ordinato più volte di ritirarsi, non è stata impiegata in molte occasioni la Guardia nazionale per difendere proprietà e vite dei cittadini e i procuratori (Democratici) non hanno perseguito i responsabili delle violenze, trincerati dietro l’alibi dell’assassinio del cittadino afroamericano. Di più, il presidente Biden ha detto pubblicamente che i rivoltosi andavano ascoltati e dalla sua campagna presidenziale molte sono state le donazioni ai legali impegnati a scarcerare gli autori delle rivolte. I grandi network hanno seguito l’onda, mentendo spudoratamente quando affermavano che le manifestazioni erano pacifiche: in tempo reale i cellulari riprendevano vere e proprie scene di guerriglia urbana. Ma si sa, i due pesi e le due misure sono il must di questa narrazione, così Chris Cuomo si chiedeva alla CNN, senza il minimo imbarazzo: “Dove sta scritto che le proteste devono essere educate e pacifiche?”. Un’estate incendiaria e folle che ha innescato nuovi sentimenti, di parte avversa, dopo decenni di attacchi subiti da parte delle élite di privilegiati economici e sociali. Emblematica la frase pronunciata da Alan Friedman ieri sera in televisione, il punto più basso e volgare del giornalismo: “Ci sono gli americani che leggono e hanno cultura, poi ci sono i bifolchi ignoranti che votano Trump”. Ecco, questo è in sinesi l’approccio degli ultimi decenni in America, e non solo, nei confronti delle classi sociali meno abbienti, dei lavoratori, di milioni di cittadini sempre più sudditi che fanno fatica ad andare avanti e a garantire un futuro dignitoso ai propri figli. Non è certo populismo il mio ma una semplice constatazione dei fatti: da almeno un ventennio tutti i partiti di sinistra hanno abbandonato il loro storico elettorato per difendere gli interessi del grande capitalismo moderno. Assieme ai partiti si sono schierati anche tutti i loro lacchè che per questioni professionali – gli ambiti contratti presso i grandi giornali e le televisioni – costruiscono la narrazione del “politicamente corretto” giorno per giorno. La macellerai sociale celata dietro al paravento dei diritti civili è la loro massima impresa, nella quale è stato coinvolto il cinema e tutta la mastodontica macchina dello showbiz americano. In nessun’epoca storica i ricconi sono stati ricchi come lo sono adesso, mai ci sono stati i Bezos e i Musk con tanto denaro e tanto potere da sovvertire ogni ordine precostituito. Eppure, una parte notevole del popolo – 74 milioni di elettori che hanno votato Trump – non ci sta più e pretende un cambiamento. Vogliono essere rispettati e sono stanchi, esausti, degli attacchi dei radical chic che li dipingono come una massa amorfa e idiota da sottomettere con ogni mezzo. Sicuramente l’assalto al Congresso è stato un clamoroso autogol che presumibilmente segnerà la fine di Trump e del trumpismo, però i gravi problemi che spaccano profondamente la società americana permangono e saranno sempre più incandescenti. Anche se per decenni le masse sono state anestetizzate con i dogmi del consumismo e recentemente rimbecillite con i compulsivi acquisti on line, non si potranno controllare a lungo con tali metodi e l’establishment questo l’ha ben compreso: ho visto tanti volti noti pallidi e terrorizzati ieri sera in televisione. Difficile dire come andrà a finire, azzardo però una previsione: Biden non si discosterà troppo dalla politica trumpiana su certi argomenti. Mi riferisco ai rapporti con la Cina che rimarranno tesi e alla politica migratoria che resterà rigida, anche se coperta da una leggera coltre intessuta di ipocrisia. In Italia nessuna conseguenza, siamo e restiamo la Nazione della paranoia e della sottomissione al terrore inculcato. Lo spirito di gregge regna sovrano tra il popolo italiano, totalmente acritico e compresso in una vita puramente biologica e stretta attorno al potere corrente a cui tutto si concede. No, decisamente noi non siamo l’America.
Le vite degli altri (Trieste, 17 ottobre 2020)
L’indimenticabile film di Donnersmarck, Le vite degli altri, è il titolo migliore per rappresentare la situazione italiana di questo periodo. La pellicola vincitrice del Premio Oscar racconta i metodi della Stasi nella DDR, la Germania dell’Est, ancora negli anni ’80. Il controllo, le intercettazioni, la paranoia del regime schiacciano le vite dei protagonisti e li trasformano in mere pedine nelle mani di un ordine superiore. Nella triste e grigia storia emerge la figura umana del carnefice che si trasforma in salvatore, regalando alla narrazione quel barlume di fiducia nella coscienza civile di cui tutti abbiamo bisogno. Sentendo alla televisione il ministro Speranza, uomo grigio e cupo, il classico cittadino dal percorso fallito che trova nella politica il riscatto e la vendetta, sono ritornata in un istante alla mia infanzia negli anni in cui Le vite degli altri è ambientato. Senza alcuna esitazione, senza provare il minimo imbarazzo, il ministro ha chiesto ai cittadini di denunciare i loro vicini di casa alla polizia se si azzardano ad organizzare un pranzo o una cena con più di sei invitati. Nei giorni successivi si è scatenato un putiferio che ha messo in luce una cosa ormai chiara: giornalisti, commentatori, una parte consistente del popolo italiano, persino uno storico divulgatore scientifico, si sono schierati dalla parte del ministro e del suo concetto delle Istituzioni. L’abuso di potere, la violazione dello spirito della Costituzione, il buon senso delle persone pensanti negato, il concetto di democrazia umiliato, tutto accettato e le regole democratiche gettate nel cesso con sommo compiacimento. L’avvocato del popolo che un fallito di certo non è, ha compreso subito che essere furbacchioni significa mettere le mani avanti: ha convocato il ministro Lamorgese, snobbata alla grande da Speranza e Franceschini che volevano questo “capolavoro di delazione” nel Dpcm e, cosa ben più furba, ha chiesto al capo della polizia Gabrielli un parere. Come riportato dal quotidiano Il Riformista, quest’ultimo piuttosto seccato avrebbe risposto che la polizia non è preposta ad impicciarsi nelle liti condominiali tra cittadini, ma ha ben altri problemi da risolvere (criminalità organizzata, immigrazione, terrorismo, ecc.). Conte ha indetto una conferenza stampa dove ha dichiarato che mai e poi mai il suo governo avrebbe mandato la polizia a casa dei cittadini (te credo! Sa bene che ci vuole ben più di un decreto, serve l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria) e il ministro Speranza è stato costretto a rimangiarsi tutto, ovviamente dicendo che lo avevano frainteso. Questo fatto imbarazzante non è isolato ed è assolutamente inquietante. Ormai in Italia si parla di “coprifuoco” a livello nazionale, dell’attività produttiva che rischia un nuovo e fatale fermo, delle vite degli altri in mano a tragiche figurine dittatoriali e tutto questo consentito dall’isteria collettiva, dalla psicosi da virus costruita dal terrorismo mediatico e oramai fuori controllo. Proprio oggi, mentre sto scrivendo, leggo di una zuffa su un autobus di Trieste. Una donna senza mascherina è stata aggredita e pestata da un’altra, finendo all’ospedale. Il senso della realtà, della proporzione erano già carenti da tempo, adesso pare siano svaniti del tutto. E giù ad attaccarsi gli uni con gli altri, a cercare l’untore da crocifiggere, a vomitare insulti su bar e ristoranti che si lamentano, senza mai chiedersi di chi è la colpa per i ritardi nella sanità e negli ammortizzatori sociali. Si sa, l’Italia è quel paese col numero record di impiegati statali, di pensionati, di società partecipate statali, di fruitori del reddito di cittadinanza, e queste categorie si sentono meno colpite delle altre se chiude tutto, poiché i soldi arrivano lo stesso. Tuttavia, se le aziende private falliscono anche lo Stato finisce in default e di redditi sicuri, in quel caso, ne rimangono ben pochi. Però questo non sembra preoccupare troppo ed è comprensibile, adesso il problema è il virus e l’unico pensiero che tormenta certe coscienze è la paranoia. Chiunque provi a dissentire, a ragionare, a proporre una lettura diversa viene accusato di essere un “negazionista”, incluso chi il virus lo ha avuto o chi lo cura negli ospedali ma non per questo si presta alla narrazione isterica. Capita così che i video dello scrittore Nicolai Lilin vengano rimossi dal noto social network e che gli utenti lo riempiano di insulti, reo di aver detto la sua senza offendere nessuno. Mi viene in mente un brano importante riportato dal libro Nuremberg Diary riguardo al Processo di Norimberga. Lo psicologo americano Gustave Mark Gilbert incontrò in quell’occasione Hermann Göring, il “Maresciallo del Reich”, e scrisse la loro conversazione.
Göring: “Ma è ovvio, la gente non vuole la guerra. Perché mai un povero contadino zoticone vorrebbe rischiare la propria vita in guerra quando il meglio che gli possa succedere è tornare alla sua fattoria sano e salvo? Naturalmente la gente comune non vuole la guerra. Non la vuole in Russia né in Inghilterra né in America, e neanche in Germania, per quel che vale. Si capisce. Ma dopotutto sono i leader del Paese che determinano le politiche, ed è facile trascinare la gente dietro a tali politiche, sia tale Paese una democrazia o una dittatura fascista o un Parlamento o una dittatura comunista”.
Gilbert: “C’è una differenza. In una democrazia la gente ha diritto di dire la propria sulla questione attraverso i suoi rappresentanti eletti, e negli Stati Uniti solo il Congresso può dichiarare guerre”.
Göring: “Oh, tutto questo è bellissimo, ma, che abbia o meno diritto a dire la propria, la gente può sempre essere trascinata dai propri leader. È facile. Tutto quello che c’è da fare è dire alla gente che sta per essere attaccata, denunciare i pacifisti per mancanza di patriottismo e perché mettono in pericolo il Paese. Funziona allo stesso modo in qualsiasi Paese, che sia una democrazia, una monarchia, una dittatura. Bisogna spaventarli, inculcargli la paura, bisogna imbottirli di paura come si fa con le oche finché non gli scoppia il fegato per fare il paté, bisogna fare in modo che quella paura fermenti e si trasformi in odio, un odio assoluto, irrazionale, sguaiato”.
Società dispotica e furia iconoclasta (Trieste, 23 agosto 2020)
Tardo pomeriggio di agosto, sole ancora infuocato con quaranta gradi sull’asfalto, oltre trenta all’ombra se tutto va bene. Sono in giro con i cani, in cerca di aiuole verdi e di alti alberi che facciano ombra. Mi sento in colpa, ho portato gli animali a passeggiare col caldo e anche se sono passate le sei l’intensità dell’estate è forte. Cammino in un immenso spiazzo, un parcheggio enorme e inutilizzato, circondato da terreni incolti e giardini con tigli rigogliosi. Non si sente un filo d’aria, un minimo di brezza anche se siamo a poche centinaia di metri dal mare. Non c’è anima viva, sembra una porzione di città spettrale, con il solo rumore delle macchine sulla tangenziale vicina. Ed ecco comparire una figura solitaria: riemerge da una piccola galleria che collega il grande parcheggio con un altro più piccolo e ugualmente desolato. Quindi appare un uomo anziano, curvo dagli anni e da un lavoro logorante, con pochi sparuti capelli bianchi in testa. Penso che avrà pressappoco un’ottantina di anni, però è difficile dirlo: indossa una enorme mascherina bianca, sagomata, che gli copre la faccia fino agli occhi. Cammina barcollante, si intuisce che respira malissimo ed è paonazzo. Non mi vede, prende la salita costeggiata da alte acacie e si incurva ancora di più, respira sempre peggio a causa dello sforzo. Dalla galleria sbuca una vecchia Golf di colore rosso, con i finestrini rigorosamente chiusi e un altro vecchio alla guida, con la mascherina che gli copre la faccia. Questo mi guarda e rallenta, sento il suo sguardo rabbioso, di condanna, e il sottotitolo dei pensieri che gli frullano nella testa: “Ma guarda questa cretina con i cani, sono le sei passate e lei esce senza la mascherina!”. Accelera e prende la salita, per poco non investe l’altro poveraccio che, barcollante, zigzaga in mezzo alla strada. Sento i forti colpi di clacson e immagino gli insulti soffocati dalle mascherine. Questa per me è stata la scena, la rappresentazione più tragica dell’infelice momento che stiamo vivendo. Vorrei che il Covid-19 fosse il nostro più grande problema, lo vorrei davvero. In fondo si tratta di un virus, una categoria di organismi potenzialmente pericolosi con i quali conviviamo da molto prima di evolverci in Homo Sapiens sottospecie Sapiens. Nella tragicomica scena dei vecchi che rischiano un infarto, la morte per soffocamento in una macchina chiusa e senza aria condizionata o un investimento nella zona più desolata di Trieste, ho visto la resa catastrofica di una società al collasso, prona al dispotismo peggio costruito di tutti i tempi e con le finalità più bieche: la dittatura sanitaria in tutta la sua meschinità. Anni fa, un professore di Filosofia all’Università di Trieste ci disse che non dobbiamo essere tanto ingenui da credere di non rischiare una deriva autoritaria nei Paesi occidentali, l’insorgere di una dittatura brutale che incenerisca tutte le conquiste civili ottenute fin ora: il tempo dei regimi dispotici non è mai finito e la figura del despota non ha mai smesso di esercitare un certo fascino sinistro. Malauguratamente il professore ci ha lasciato diversi anni fa, oggi credo che, nonostante il suo acume e la lungimiranza, sarebbe profondamente sorpreso dagli sviluppi. Infatti, qui non si sta prospettando soltanto una società dispotica capace di superare la fervida immaginazione di Ray Bradbury (Fahrenheit 451) o Aldous Huxley (Il Mondo Nuovo), qui ci si scivola tutti dentro, intorpiditi (nella migliore delle ipotesi), o addirittura entusiasti di finire a vivere in un nuovo ordine dove la volontà del singolo essere umano è osteggiata e condannata, così come il libero pensiero è classificato come “criminale” e “reazionario”. Una società dove la volontà non esiste più, ci si accontenta di soddisfare i bisogni primari, si segue il gregge e si venera il pastore/carnefice. Poi, occorre affidarsi alla pletora di esperti, certamente! Quelli che capiscono la situazione e mettono i pupi a nanna, drogandoli di statistiche e spaventandoli col virus nero. Da sempre le masse – piccole o grandi che fossero – si sono tenute sotto controllo col terrore: la magia dello stregone nelle tribù primitive, le divinità nel mondo antico, le religioni monoteiste in quello medievale e moderno, le ideologie in tempi più recenti. Le classi sociali dominatrici si sono formate all’ombra del terrore, lo hanno utilizzato con profitto in tutte le epoche, intuendo quanto fossero irrazionali le paure dei subalterni. La malattia contagiosa ha esercitato un particolare ascendente sulla creazione della paura, della fobia collettiva. Nel Medioevo si diceva: “A peste, fame, et bello, libera nos Domine!”, un’invocazione d’aiuto rivolta a un Dio misericordioso che però sapeva anche castigare. Potenti erano le pestilenze, i contagi fuori controllo, le ondate di malattie infettive che colpivano l’Europa e che l’acume dei Veneziani provò ad arginare inventando la quarantena nel 1448. Anche allora come oggi si cercava l’untore, il bastardo che contagiava per divertimento o per cattiveria, qualcuno tipo il viscido essere che alle sei di sera esce con i cani senza la mascherina o che si permette di fare un viaggio all’estero dopo essere stato rinchiuso in casa per mesi. Si pensava che la scolarizzazione, l’apprendimento, la cultura potessero creare un minimo di capacità critica nelle masse, pur subalterne ed economicamente fragili, e invece è accaduto tutto l’opposto: il poveraccio che vive in un condominio-dormitorio, in un appartamento di 50 metri quadri, è contento di starsene rinchiuso fino almeno al 2021, rinunciando allegramente a tutti i suoi diritti di cittadino e cantando sul balcone “andrà tutto bene”. Nessun dubbio sfiora questo essere così semplice e malleabile, nessun senso di rivolta cova nella sua mente, nessun quesito lo disturba mente si rincoglionisce di cibo spazzatura, di serie televisive trash e di social network per ritardati. Perché se solo si sforzasse di pensare un po’, se gli girassero i cosiddetti quando sente paragonare l’attuale pandemia alla terribile febbre spagnola del 1918-20, un minimo di sussulto gli verrebbe. Voglio ricordare che l’influenza spagnola uccise 50 milioni di persone su una popolazione mondiale di 2 miliardi, fece apparire la Prima guerra mondiale come un fatto marginale e ammazzò soprattutto i giovani. In Italia i morti furono 600 mila, su una popolazione di poco meno di 40 milioni di abitanti (Cenni sulla pandemia “spagnola”: riflessioni su alcune fonti d’archivio parlamentari di Pierpaolo Ianni – Trimestrale dell’Archivio storico del Senato della Repubblica – n.30 Nuova Serie, giugno 2020). Da questi dati si può capire, senza sforzare troppo le meningi, che paragonare la situazione attuale a quella dell’influenza spagnola è un insulto all’intelligenza. Tenendo anche conto che non fu l’unica pandemia del secolo scorso, visto che nel 1957-58 arrivò la pandemia di influenza asiatica e dieci anni dopo si ripresentò con la variante di Hong Kong (oltre un milione di morti nel mondo e almeno 20 mila vittime in Italia). La Svezia fu molto colpita da questa aviaria che degenerava in polmonite e che uccideva soprattutto gli anziani e i malati. Il grande Ingmar Bergman girò in quel periodo uno dei suoi capolavori: Il settimo sigillo, dove un maestoso Max von Sydow, cavaliere medievale, sfidava la morte in una partita a scacchi per sfuggire alla peste. Eppure, neanche l’evidenza più lampante, nemmeno la spiegazione dettagliata mettono in crisi il credo granitico del sempliciotto convinto che si faccia tutto quanto per il suo bene. Così appaiono nuove figure, giovani masse acritiche che hanno trovato un modo violento per sostenere l’ordine dispotico, la deriva e lo scivolamento verso la melma maleodorante del pensiero unico, travestendosi da “rivoluzionari per i diritti civili”. Da tempo abbiamo notato la tecnica di imporre una spaventosa macelleria sociale e coprirla col paravento dei diritti civili, condannando di fatto le classi lavoratrici a fare turni assurdi nelle aziende a fronte di guadagni sempre più ridicoli. Una tecnica collaudata che ha portato il signor Bezos, mister Amazon, l’uomo dai 100 miliardi di dollari (e che ne ha guadagnati altri 25 ai tempi della pandemia), capace di schiavizzare milioni di dipendenti globalizzati, a comperare il Washington Post, quotidiano ultra-liberal, da dove urlare a Trump tutto il disprezzo del mondo e dargli del bianco miliardario privo di scrupoli e razzista. Non so però in quanti si aspettavano che i giovani “fake-revolutionaries” di cui sopra, avrebbero tratto ispirazione dai metodi dell’Isis per devastare i monumenti nelle città, prima in quelle americane e poi, di riflesso, anche nella vecchia e patetica Europa. Buttare giù le statue di Cristoforo Colombo dev’essere stata una gran gioia per questi acritici ignoranti, a digiuno anche di un’antologia di storia per le elementari e privi di qualsiasi acume in grado di spingerli a collocare storicamente la figura del navigatore genovese. Come disse Roberto Benigni a Massimo Troisi nel leggendario film “Non ci resta che piangere”: Volevo fermare Colombo perché così quell’imbecille (americano) non sarebbe mai nato!”. Purtroppo, queste masse giovanili dai cervelli precocemente atrofizzati, fanno bella mostra di sé anche in Europa, e ci tengono a mostrare il loro buon gusto imbrattando le statue di Churchill e di Montanelli in Italia. Sono degli utili idioti al servizio di un potere sempre più grande e informe, capace di contare su fondi economici illimitati e di infarcire di becera retorica la narrazione mainstream alla quale i media si sono prontamente adeguati. Ciò che mi stupisce e mi lascia perplessa è la resa totale e incondizionata di popoli interi – quello italiano è in assoluto il più rappresentativo – a questa insana deriva della società e dei rapporti tra il potere rappresentativo e la popolazione. Se qualcuno sente nell’aria l’odore della rivolta, della rivoluzione, buon per lui, io nell’aria sento solo l’odore stantio e asfittico della resa. Il mito della caverna di Platone in tutta la sua reale e spaventosa rappresentazione.
“Un posto dove si mangia, si dorme e si muore” (Trieste, 24 aprile 2020)
Da settimane ormai ci arrivano notizie della lenta e costante strage di vecchi nelle case di riposo, con il solito scarica barile sulle responsabilità, le colpe, le negligenze. Questa storia è iniziata con frasi del tipo: “Tanto muoiono solo i vecchi”, “In casa confinati ci dovrebbero stare soltanto loro”, “I vecchi rompono le palle nei supermercati” e altre delizie tipiche di una società composta da rozzi, cibernetici imbecilli che al mondo servono quanto la polmonite serve ai polmoni. Una profonda antipatia nei confronti degli anziani che hanno risollevato l’Italia in anni difficili la si percepiva da tempo, perché l’utile idiota invece di prendersela con chi lo farà lavorare fino a quando schiatterà sul posto di lavoro (se ne ha uno), preferisce prendersela con suo nonno che magari gli dà pure una parte della pensione. Riflettendo su queste forme brutali e decerebrate di egoismo, mi è venuto in mente un fatto importante della mia giovinezza risalente a più di vent’anni fa. All’epoca mia madre lavorava nella portineria di uno stabile signorile di Trieste; un palazzo pieno di uffici, studi, abitazioni borghesi e anche una grande casa di riposo piena di gente. Un giorno la sostituivo perché era impegnata a casa di un condomino quando, davanti al vetro della portineria, apparve il volto rugoso e smarrito di una donna anziana. Con voce flebile e spaventata mi disse: “Dove devo andare? Mi aiuti, non so dove andare”. Mi precipitai fuori da quel angusto spazio, percependo qualcosa di serio nell’aria, senza capire di cosa si trattasse. Compresi subito che la donna era confusa perché formulava frasi senza senso e pareva anche terrorizzata. La feci entrare nel poco spazio che ospitava una scrivania e due sedie e l’aiutai ad accomodarsi. Tremava e camminava con fatica. Aveva i capelli leggermente in disordine ma l’abbigliamento di ottima fattura mi faceva supporre che si trattasse di una persona con dei mezzi. Stringeva al petto una borsetta di pelle nera, aveva un vistoso braccialetto d’oro al polso ma la nota stonata era ai piedi: un paio di ciabatte da casa. Le chiesi: “Signora, ma da dove viene?”, lei rispose con una frase che mi ha segnata per sempre e che tuttora sento marchiata nell’anima. “Vengo da un posto dove si mangia, si dorme e si muore”. Non l’avevo vista scendere le scale che conducevano ai piani superiori e non avevo capito che non veniva dall’esterno ma dall’interno: era ospite della casa di riposo. Aveva messo il suo tailleur sartoriale che forse indossava per andare al liceo ad insegnare, il bracciale che le avrà regalato il marito per i venticinque anni di matrimonio, la borsetta di pelle che conteneva il trucco e il libretto degli assegni: si era solo dimenticata le scarpe eleganti di lacca. Mi vennero le lacrime agli occhi e un nodo alla gola quasi mi strozzava. Chiamai la casa di riposo e dopo poco arrivò l’infermiera che riaccompagnò la donna nella stanza dove era confinata. Prima di andare via volse lo sguardo verso di me, uno sguardo stanco e triste, desideroso di spegnersi, e disse: “Grazie signorina”. Non ho mai saputo chi fosse, la sua storia, i suoi sogni, però l’ho immaginata tante volte. Una donna sicuramente attiva, curata, colta (si esprimeva in italiano e non in dialetto), magari frequentava il teatro Verdi o il Rossetti e andava in vacanza a Montecatini. Sarà morta da tantissimi anni ma nella mia memoria vive ancora. Pensai che mai e poi mai i miei genitori sarebbero finiti così, parcheggiati in un luogo dove si mangia, si dorme e si muore, perdendo gli affetti e alla fine anche la dignità. Quando mi è capitato ho agito coerentemente con i miei sentimenti e decisioni, alzandomi all’alba per prendere l’autobus e andare da mio padre ad assisterlo nel momento più buio della sua vita. Quel giorno di tanti anni fa ho promesso alla sconosciuta dagli occhi morenti che l’avrei fatto e così è stato. Ho una madre anziana, lucidissima e autosufficiente però con tutte le fragilità di una donna che ha superato gli ottant’anni, e mi chiedo: come fanno a mettere persone così nelle case di riposo? Il problema non è il virus, bensì le debolezze della società: la malattia colpisce nel punto in cui il sistema di vita moderno è massimamente fragile. Così ripenso a quando ero piccola e alla vita in campagna dove gli anziani rappresentavano una grande risorsa. Si portava rispetto ai vecchi, li si ascoltava, pur seguendo la propria strada. Aggiungo un’immagine a questa narrazione, uno scatto proveniente da quel mondo antico, un’istantanea che cattura tutta la bellezza in bianco e nero.
D’estate ci si trovava davanti a casa, seduti sulle sdraio con i fili di plastica e le mura secolari alle spalle. Avevo l’abitudine di ascoltare per ore i vecchi che raccontavano un mondo lontano, diverso, pieno di magia. C’era chi veniva da Firenze e ogni giorno inventava apposta per me una fiaba, oppure chi viveva in America e mi raccontava la grandiosità dei grattacieli. Nonna Eufemia mi insegnava a cucinare, nonna Maria mi comperava tovaglie e asciugamani per il corredo, zia Libera mi spiegava le erbe officinali e mi raccontava la storia della sua incredibile vita. Nell’alloggio del signor Giacomo e della moglie Maria mangiavo gli spaghetti col peperoncino che mi facevano lacrimare gli occhi, mentre barba Mario nelle fredde mattine invernali mi faceva sedere sulla panca del suo antico fogoler. Non sarei la persona che sono senza i vecchi, non avrei imparato quel milione di cose che loro hanno avuto la bontà di insegnarmi. Per questo, come per tante altre cose, non capisco l’Italia di oggi. Un paese che si ostina a parlare di famiglia e poi abbandona i nonni e i genitori dentro luoghi più simili a gabbie che ad abitazioni, dovrebbe come minimo fare una seria riflessione sugli effetti di questa crisi sanitaria. Come ho già detto, dalle disgrazie si dovrebbero trarre degli insegnamenti, pensare, fare anche qualche mea culpa e cercare di cambiare le cose che non vanno. Tutti dicono di non avere tempo, di essere di corsa, per questo non leggono o vedono un museo, però sono sempre pronti a fotografare la bistecca al ristorante e piazzarla sui social network ai quali, per altro, sono costantemente connessi; allo stesso modo non possono occuparsi dei vecchi che hanno troppe esigenze e rompono le scatole, in compenso si prendono il cane e lo portano a pisciare diverse volte al giorno, perché mica si può stare soli, no? Ho cani e gatti a casa, lavoro sempre, ma finché avrò vita mia madre non sarà mai sola. Non sono un’eroina e nemmeno una super donna, sono solo una figlia e soprattutto un essere umano. Torniamo davvero a ciò che eravamo e che la strage nelle case di riposo ci insegni qualcosa.
A peste, fame et bello libera nos Domine (Trieste, 16 marzo 2020)
Questa era la preghiera, l’invocazione del popolo nel Medioevo, la supplica a Dio affinché salvasse l’uomo dai flagelli più temuti: pestilenze, fame e guerra. Nelle chiese medioevali e rinascimentali abbondano gli affreschi dedicati ai santi protettori, alla Beata Vergine, allo Spirito Santo che purifica il mondo e lo salva dalla peste e dal colera. San Giorgio a cavallo, nel gesto di trafiggere il drago ai suoi piedi, a mio avviso è la migliore rappresentazione dell’uomo che lotta contro un male invisibile e funesto, capace di distruggere ogni cosa. Ci troviamo oggi ad affrontare una nuova pestilenza, nelle nostre società ancora ricche e opulente dove la fame e la guerra sono sconosciute, ma dove le antiche paure dimorano ancora dentro di noi. L’ateismo, l’individualismo, l’egoismo portato al limite, il cinismo asceso alla migliore delle virtù impediscono di chiedere clemenza a Dio, poiché troppa è la spavalderia dell’occidentale, troppa la sua spocchia per affidarsi alla pietà divina. Eppure, il dio denaro che tanto veneriamo e per il quale siamo disposti a tutto, non ci aiuta adesso; il feticcio dorato delle Borse che precipitano, dei miliardi che vanno in fumo, dei broker che si strappano i capelli davanti ai monitor in cristalli liquidi, sono lo specchio di una società fragile e debole che si scopre impotente in balia della primordiale forza distruttrice della natura: i virus. Organismi semplici, i primi abitatori di questo nostro magnifico pianeta, capaci di distruggere organismi complessi grazie alla loro essenzialità, senza remore e senza fretta. Negli anni ’50 mia madre si ammalò della tremenda asiatica, un’influenza aviaria giunta anch’essa dalla Cina. Fu un’esperienza tremenda, la febbre altissima che provocava delirio, dolore alle ossa che sembravano spezzarsi e il terrore che il male sfociasse in polmonite e portasse alla morte. Morirono a milioni nel mondo, fu una tragedia di cui rimane poca memoria. Si ricorda di più la febbre spagnola, così la chiamavano le mie nonne e la prozia Libera, facendosi la croce. Arrivò alla fine della Grande Guerra e fu una catastrofe planetaria. Qualche fonte parla di 50 milioni di morti, altre di 100 milioni. La spagnola uccise tantissimi giovani sopravvissuti alla guerra, portò nella tomba bambini e adulti, aggiungendo distruzione e morte ad un secolo funesto come pochi. Facendo delle ricerche presso i registri parrocchiali del mio paese natio, Stridone, ho trovato il passaggio della spaventosa epidemia di colera del 1830. Il prete celebrava anche tre funerali al giorno e lo annotava nel “Registro dei Morti”, elencando nomi, età e causa della morte. Tra il mese di luglio e agosto di quell’anno, Stridone e i suoi dintorni si spopolarono, il morbo uccise vecchi, donne, uomini, bambini, neonati, lasciando le case vuote e i campi incolti. Andando indietro nel tempo troviamo tanta di questa agghiacciante contabilità, nelle ondate di peste per esempio, di cui abbiamo notizie dai tempi dei Romani fino al romanzo di Manzoni. Rifletto su tutte queste cose nei giorni da reclusa che sto vivendo, così come pure ne ricorderò tante, come spero anche voi che mi leggete. Ricorderò che mi sono ammalata di tonsillite e bronchite e che ho avuto paura, non tanto per me quanto per la mia anziana madre che stava anche peggio. Ricorderò di aver chiamato il 112 per lei e che l’ambulanza l’ha portata all’ospedale nel giro di mezzora, dove medici e infermieri l’hanno assistita e controllata senza pensare che è vecchia e che ha fatto il suo tempo: loro al Giuramento di Ippocrate credono ancora, alla legge di Darwin cara ai nazi-britannici molto meno. Poi ricorderò la bestialità dell’Europa che non è degna di questo nome, delle mascherine comprate dall’Italia e bloccate, dei confini sbarrati, degli italiani ridicolizzati da squallidi mangia-rane d’oltralpe, della donnaccia a capo della Bce, laida e lurida nonostante i completini Chanel, nell’atto di accoltellare il Paese in cui è nata l’utopia del continente unito. Non dimenticherò chi ha descritto il popolo italiano come untore, propagatore di malattie, sporco e farabutto, da chiudere e isolare e mortificare in ogni modo (dal parmigiano “virus free” ai camion di merci bloccati ai valichi). Non dimenticherò nemmeno i traditori nostrani, coloro che anche in momenti come questi non perdono occasione per mantenere vivo il clima di perenne guerra civile, da Guelfi e Ghibellini, o per meglio dire da capponi di Renzo (I Promessi Sposi) che si beccano tra di loro fino all’ultimo istante, fino a quando non finiscono sotto la scure del macellaio. Ricorderò anche altro però. Il silenzio della notte, l’aria pura come quella della mia infanzia, l’assenza di rumori, il suono del vento tra i rami spogli che iniziano a germogliare. Poi il profumo del mare che entra dalla porta del terrazzo, il canto degli uccelli, i primi fiori gialli che abbelliscono il mio piccolo giardino da vaso.
Finirà come sempre finiscono le pestilenze, lascerà morte e macerie, la cenere nelle nostre anime, ma anche il desiderio di ricominciare, di rimettersi in piedi e continuare a vivere. Gli equilibri della natura sono complessi da comprendere, sembrano crudeli e punitivi e incapaci di alcuna pietà verso le creature che soffrono. Eppure, da ogni tragica esperienza, la storia ce lo insegna, sorge un nuovo mondo, nasce una nuova via da esplorare e percorrere, poiché le incognite sono uno stimolo e la ricerca della bellezza una necessità. Non dimentichiamoci chi siamo, la nostra cultura, i nostri lasciti al mondo intero: quando i Romani costruivano gli acquedotti, i ponti ancora esistenti, scrivevano le leggi e fondavano la civiltà occidentale, le bestie galliche e germaniche vivevano nei tuguri, vestivano con pelli di animali ed emettevano suoni che non sapevano scrivere. Per Dio, ricordiamocelo qualche volta! Possiamo avere anche i tratti longobardi e un ridicolo cognome slavo come la sottoscritta, ma culturalmente apparteniamo a qualcosa di grande che va omaggiato, celebrato e protetto. Facciamolo ora, adesso, senza indugi. Amiamo noi stessi e le nostre tradizioni, solo da queste ripartiremo a sciagura finita.
La chiesa di “bella ciao” (Trieste, 28 novembre 2019)
Era su tutti i giornali, nei numerosi contenitori politici alla televisione, sui social network che raggiungono chiunque: a Pistoia, durante la messa, il prete Biancalani ha intonato “bella ciao” a fine funzione. Biancalani è noto per le sue posizioni politiche radicali e di sinistra e per la sua antipatia per nulla celata nei confronti delle formazioni di destra (Lega in primis) che non esita a definire “fasciste”. Fa parte di quella tradizione tosco-emiliana di sacerdoti appartenenti alla “Chiesa del dissenso”, in dialogo con il PCI, dove l’ideologia comunista non di rado veniva sposata per contrapposizione alla Democrazia Cristiana. Il PC, come noto, era un partito molto forte in Italia e anche ben definito, con un articolato apparato di segreteria e di ideologia e non era insolito che la tessera di quel partito portasse benefici. In un programma mattutino di un paio di giorni fa, Biancalani arriva a citare a sproposito la figura di Don Milani che, come sottolinea un mio amico religioso, è sempre stato strumentalizzato da una certa sinistra, poiché non era né di destra né di sinistra. All’epoca la Chiesa del dissenso voleva distanziarsi dalla Chiesa pacelliana, piramidale, per una Chiesa evangelica, mai e poi mai comunista, semmai comunitaria, come avrebbe voluto il filosofo cattolico Jacques Maritain. Oggi gli eredi di quella Chiesa trovano, a mio avviso, nella figura di Bergoglio la spinta ad estremizzare certe visioni del passato, visioni che farebbero inorridire Giovanni Paolo II che sul comunismo aveva idee ben chiare. Il prete toscano arriva a dire che lui ha l’obbligo di seguire il Vangelo e la Costituzione, ovviamente solo nella parte della sua ispirazione antifascista, perché il resto non mi pare susciti la sua ammirazione, date le posizioni oltranziste di chiusura verso chiunque la pensi diversamente. Ascoltandolo esterrefatta, annichilita dalle sue assurde argomentazioni, ho ripensato alla mia infanzia in un paese del socialismo reale, governato dall’unico e solo partito comunista. A scuola, da bambina, mi imponevano quella canzone, “bella ciao”, inno delle brigate partigiane italiane in Istria, i cui vertici, come quello della Budicin, furono decapitati dalla polizia militare di Tito proprio perché italiani. Gli insegnanti mi imponevano con un ghigno cattivo quella canzone ed erano gli stessi che mi obbligavano ad andare a scuola il giorno di Natale; un giorno come un altro per loro, però “rallegrato” sempre da un’interrogazione o compito in classe, perché occorreva punire chi andava alla messa di mezzanotte. L’albero di Natale a scuola si faceva il 26 dicembre e si chiamava “albero di Capodanno”; nella loro immensa ignoranza non sapevano quanto fosse simbolico quel giorno, il primo martire della cristianità, come eravamo martiri anche noi bambini in quel sistema folle che voleva sostituire il cattolicesimo col marxismo e definiva la fede “oppio dei popoli”. La follia assumeva forme grottesche inquietanti, come Babbo Natale che diventava “nonno inverno” o “nonno gelo”, aveva una ridicola veste da vescovo, tipo S. Nicola, senza la croce ma con una vistosa stella rossa.
Vorrei spiegare a Biancalani che i più grandi nemici della nostra religione nel secolo passato erano i regimi comunisti, quelli che ammazzavano i preti, abbattevano le chiese, eliminavano le Bibbie da tutte le biblioteche, tentavano di cancellare millenni di tradizione e di fede al canto di Internazionale, bandiera rossa e anche bella ciao. Penso però che sarebbe del tutto inutile spiegarglielo, ha tentato anche il vescovo di richiamarlo all’ordine ma non è servito. La Chiesa di oggi mi getta in un grave stato di confusione: non desidero più andare a messa, almeno non nelle chiese cattoliche. Spero che Dio mi perdoni per quella forza persa che avevo da piccola, quando a messa a mezzanotte ci andavo con orgoglio. All’epoca c’era il papa polacco, Giovanni Paolo II, un faro per tutti noi. In questo tempo di Avvento non posso non tornare a parlare del triste Natale in Jugoslavia, forse il momento dell’anno in cui la nostra infelice situazione si manifestava maggiormente. Era tragico il Natale, lo era in tutti i suoi aspetti. Nessuna luce, nessuna luminaria, nessun albero pubblico, nessun canto che usciva dalle chiese chiuse con i fedeli dentro. Sono certa che Don Milani avrebbe capito la nostra frustrazione, l’idea di comunità che provavamo disperatamente a mantenere, nonostante gli elementi disgregativi penetrati in profondità. Proprio per questo non posso che detestare l’occidente, un mondo che non ha subito tutto ciò eppure si è svenduto indegnamente, senza remore. Per cosa poi? Per avere una società molle e perversa in declino totale? Forse sono un prodotto stanco e deluso del secolo scorso, non comprendo la resa di una società priva della capacità di combattere contro la sua estinzione. Quando stava per cadere il muro di Berlino, nei mesi precedenti, ricordo cambiamenti repentini nei sistemi socialisti, consapevoli che il gioco era giunto alla fine.
Era diventato evidente al potere che la voglia di cola e di pepsi, di hamburger, di jeans, di music cassette, di cibo spazzatura, poteva essere usata per non collassare nell’immediato: panem et circenses. In Jugoslavia però non ha funzionato per niente e nel ’91 nessuno poteva più fermare il bagno di sangue in cui sarebbero affogati tutti gli ideali marxisti di fratellanza, uguaglianza e lotta popolare comunista. Voglio terminare questo amaro pezzo proprio parafrasando Marx, riguardo alla chiesa cattolica di oggi: la sua storia è stata caratterizzata da molte tragedie ma sta decisamente finendo in farsa.
Il muro della vergogna (Trieste, 09 novembre 2019)
Per anni mio padre lo ha chiamato così, “muro della vergogna”, quello che i più definiscono Muro di Berlino. Avevo sedici anni la mattina in cui le televisioni e la stampa di tutto il mondo ne annunciarono la fine; era il dieci novembre, la notte precedente una breccia si aprì e con rapidità sorprendente tutto mutò. Si trattava dell’inizio della fine di un’era storica, di lì a poco un effetto domino avrebbe fatto capitolare i regimi del blocco sovietico e la stessa URSS. I settant’anni di marcia verso il nulla erano giunti alla fine per una serie di fortunate coincidenze e, soprattutto, perché l’ideologia comunista si era sbriciolata da tempo. Gorbaciov, Giovanni Paolo II, Reagan in visita a Berlino ovest: segnali per le masse che decisero spontaneamente di farla finita. Quella notte a Berlino poteva finire in una carneficina, tanta era la gente che premeva sul check point Charlie per passare e i tank russi erano pronti ad uscire dalle caserme. Fortunatamente la storia era cambiata e gli uomini non credevano più nella religione marxista, inclusi coloro che indossavano la divisa, così non fu sparato neanche un colpo. Ricordo una giovane e frastornata Lilly Gruber che intervistava la gente festante tra il frastuono dei clacson e le grida liberatorie ai piedi della Porta di Brandeburgo. Tutto stava cambiando, lo percepivo con chiarezza; anche se ero una ragazzina, l’entità dell’evento mi pareva enorme e comprendevo che quella storia ipocrita chiamata “marxismo” che ci insegnavano a scuola sarebbe finita ovunque. L’anno dopo me ne andai dalla Jugoslavia, nazione che dopo un paio d’anni si sarebbe dissolta completamente e non come il muro di Berlino: sarebbe finita in un bagno di sangue. Mi sentivo spaesata in occidente, non capivo la gente e le loro aspirazioni, il continuo lamentarsi per cose insignificanti, il consumismo così esasperato che non era degnamente rappresentato nemmeno nelle opulente pubblicità che vedevo alla televisione. Sono passati trent’anni da allora, tutto è mutato un’altra volta e lo spaesamento è una sensazione viva. Non comprendo l’Europa che vuole controllare i pensieri della gente, limitarne la libertà d’espressione con la scure del politicamente corretto, del globalismo santificato, della perdita di identità culturale mascherata dall’ipocrisia “no border”. Nessuno spiega ai giovani pagliacci arcobaleno e dei centri sociali che il Muro di Berlino non è stato eretto per non far entrare illegalmente la gente, ma per non far uscire milioni di tedeschi della DDR tenuti prigionieri senza nemmeno un processo (in pieno stile Stasi-Kgb). L’ideologia che ha costruito il muro della vergogna è quella comunista e le sue radici sono vive e vegete nella maggior parte dei partiti di sinistra europei. Partiti che non sono capaci di rinnegarle una volta per tutte, anzi. Vi sono formazioni politiche rappresentate nei parlamenti nazionali e in quello europeo che rivendicano con orgoglio e convinzione le radici comuniste. Per me, come per milioni di altri cittadini che hanno vissuto nel socialismo reale, queste sono umiliazioni perpetue; la nostra storia non conta, viene minimizzata se non negata e il racconto del Muro non è altro che un dovere annuale sempre più annacquato. La crisi dell’Europa – economica, politica e identitaria – non fa presagire nulla di buono per il futuro, mentre a livello spirituale il papa dell’Est che ha dato una spallata al comunismo e che raccoglieva le masse intorno a sé è lontano anni luce. Gli anni trascorsi non hanno posto sulle mie spalle solo il fardello del tempo e dell’invecchiamento, hanno anche cancellato quell’entusiasmo e quella speranza in un futuro migliore provati la mattina di quel novembre del 1989, quando non potevo neanche immaginare il vuoto e la debolezza dei giorni nostri. Un idealista che si sente libero per la prima volta in vita sua non può pensare che la libertà e l’identità si possano vendere per i petrodollari, o che la macelleria sociale si possa nascondere dietro al paravento delle libertà civili. Non rimpiango il mondo che era, la guerra fredda e l’oppressione di regime: sarei pazza o idiota se lo facessi. Di contro non posso nemmeno dire che l’Europa di oggi così com’è, ipocrita e vigliacca, incarni minimamente l’ideale di libertà a cui aspiravo. Non c’è libertà dove c’è censura delle opinioni contrarie al pensiero unico e le porte alla società descritta da Orwell in 1984 sono aperte. Il Muro di Berlino è un punto fondamentale della storia europea, sia la sua costruzione che soprattutto la sua distruzione; purtroppo la portata storica di tale evento non ha insegnato molto agli europei di oggi, privi di memoria e di progettualità. Mala tempora currunt.
Peculiarità americane (Trieste, 27 ottobre 2019)
“Leader of ISIS died like a dog, like a coward”, così dice in conferenza stampa il presidente Donald J. Trump riguardo la morte del signore dell’ISIS al Baghdadi. Sostiene Trump che il sedicente califfo sia morto piangendo e urlando, scappando in un tunnel senza via d’uscita e trascinando con sé tre dei suoi figli, presumibilmente morti quando si è fatto detonare. Lo ripete più di una volta che si tratta di una morte da codardo, da “cane”, la somma denigrazione per un fanatico islamista. Loda le unità speciali che hanno compiuto il blitz, l’intelligence, i militari e ringrazia chi ha fornito informazioni utili per la sua individuazione (a cominciare dalla Russia che però esprime delle perplessità sull’operazione). Di certo questa è una peculiarità americana: mentre noi chiacchieriamo e pontifichiamo sul nulla, loro agiscono. L’ISIS ha colpito fuori dai territori brutalmente occupati con un’organizzazione terroristica efficiente, spietata, sapientemente indottrinata e foraggiata economicamente. Ha colpito in particolare l’Europa, con azioni plateali di gruppo o individuali in Francia, Belgio, Regno Unito, Spagna, Germania, Russia, ecc., oltre che in Asia, Nord Africa, Australia e negli stessi Stati Uniti. Abbiamo vissuto anni di incertezza e di paura, ci sono stati attentati a breve distanza con moltissimi morti che hanno fatto precipitare l’Europa nel panico. Da qualche tempo la situazione sembra si sia calmata e la nostra scarsa memoria, da codardi quali siamo, ci fa sentire sicuri a casa nostra, senza chiederci ovviamente per merito di chi. Di sicuro non dobbiamo ringraziare la UE, questa macchinosa creatura nata male e sviluppatasi peggio che non prende posizione neanche con una pistola puntata alla tempia, né tanto meno l’inutile e ridicola ONU la cui esistenza ha sempre meno senso; idem la NATO, vecchio e stanco prodotto del Novecento che ha la credibilità del cartonato di una tigre degli anni ’50. Nel difficile scacchiere mediorientale hanno agito le vere superpotenze, gli USA e la Russia di Putin, con il coinvolgimento della Turchia che ci tiene per i testicoli con i profughi (quelli veri) e l’Iran che è imprevedibile in ogni sua mossa. Nella provincia di Idlib, dove il califfo è stato scovato, le organizzazioni terroristiche proliferano ancora, presumibilmente continueranno a farlo, e ciò che sappiamo noi di quella porzione sperduta del nord della Siria sono le informazioni dei media italiani che ci hanno deliziato con le facce di quattro pavoni di sinistra, con le mani sulla bocca, a denunciare il gas usato dal perfido Assad. Perché Assad era il problema, mica i terroristi che hanno offerto ospitalità al califfo (per poi tradirlo, of course!). Ebbene, anch’io, lo ammetto, ho scritto un post indignato sul ritiro degli americani dalle aree dei curdi, pensando ad un vile tradimento e con l’ingenuità di chi, pur leggendo tantissimo, delle volte si fa influenzare. Il controllo dell’area verrà ovviamente suddiviso, la Russia giocherà un ruolo fondamentale e Assad, pur ridimensionato, non lascerà il potere; i turchi poi ricacceranno i poveri siriani oltre confine, sempre che non preparino qualche bella sorpresa per il vecchio, pusillanime, vuoto e debole continente europeo. I curdi non avranno ciò che desiderano ma non per questo non rivestiranno un ruolo, basti pensare che il “tradimento” americano non ha impedito loro di collaborare all’eliminazione del califfo. Tutto insomma si svolge all’interno di un gioco di potere molto grande e imperscrutabile per la maggior parte di noi. Trump, l’uomo più odiato dalla narrazione mainstream attuale, quella del politicamente corretto e dell’autoritarismo “progressista” più viscido che si sia mai visto, ha colpito duramente e, a gran voce, ha fatto capire a tutti che gli USA ci sono ancora, eccome se ci sono, però al multilateralismo preferiscono l’unilateralismo della sua amministrazione. Intanto noi europei, impegnati a imporre tasse sulla plastica e fare previsioni sui miserandi tassi di crescita, un po’ come i bizantini che discutevano sul sesso degli angeli quando i turchi stavano per espugnare Costantinopoli, stiamo a guardare e sperare che “peste non ci incolga”. Peculiarità europee.
Il rogo del libro (Trieste, 20 maggio 2019)
I saloni e le fiere del libro, diffusi in tutta Europa e non solo, sono una vetrina importante per gli editori e in parte per gli autori. Sono soprattutto situazioni organizzate in cui si incontrano le case editrici con i distributori per decidere la diffusione di alcuni generi, di alcuni autori, per valutare quali saranno i gusti dei lettori e per avere una visione sull’editoria mondiale. Infatti, ai saloni partecipano nazioni differenti, con proposte editoriali anche insolite, che forniscono una visione globale dei fenomeni o delle crisi editoriali in svariati settori. La Fiera internazionale del libro di Francoforte (Frankfurter Buchmesse) è l’appuntamento più importante in Europa e tra i più significativi al mondo. Si tratta di una fiera molto tecnica, riservata in particolare agli editori e distributori, oltre che agli agenti letterari che fanno gli interessi degli autori da loro rappresentati. Gli espositori sono tantissimi, così come lo sono i visitatori specializzati (300 mila circa); ogni anno la fiera si concentra in particolare sulla produzione letteraria, culturale e di divulgazione di un paese. Tuttavia, annualmente, ogni padiglione è dedicato ad un argomento specifico trattato dall’editoria internazionale, dando così il senso compiuto dello stato del settore a livello mondiale. Una vera piazza del mercato globale declinata nella sua produzione più “nobile”: la cultura e la conoscenza. In Italia questa piazza prende vita al Salone del libro di Torino, seppur in dimensione più ridotta e meno globale, però con lo stesso obiettivo di fondo dichiarato, ovvero far incontrare editori, distributori, agenti letterari e scrittori. Le fiere ed i saloni dunque, per loro natura, sono aperti a tutti, raccolgono idee e progetti differenti, se non contrastanti, cercando di interpretare le correnti di pensiero in formazione e prevedendo quelle in divenire. Nessuna manifestazione quanto la fiera del libro può essere in sintonia con l’essenza dell’articolo 21 della Costituzione italiana: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Questo almeno dovrebbe rappresentare la ragion d’essere del salone di Torino. Da tempo, chi come me scrive, sa che non è così. A Torino i responsabili dell’evento sono poco ospitali con gli autori non in linea col pensiero dominante della cultura italiana, assolutamente e inequivocabilmente di sinistra, e trasformano l’appuntamento annuale in una presa di posizione politica molto chiara. Quest’anno però si è superato ogni limite e parlare di censura non basta, a mio avviso si tratta del rogo del libro sgradito. In piena e selvaggia campagna elettorale per le elezioni europee, il mostro che il salone voleva abbattere è l’odiatissimo (dall’intellighenzia) Salvini. Il suo libo-intervista, pubblicato con la fino ad allora sconosciuta casa editrice Altaforte, non poteva stare al salone, tanto meno il suo editore fascista. Chiaramente Altaforte non è più sconosciuta e probabilmente ringrazia (viste le vendite sul portale, per nulla schizzinoso, di Besoz), mentre della giornalista autrice del libro, Chiara Giannini, ne hanno parlato tutti i giornali e siti italiani, specie dopo che allo stand di Feltrinelli un’addetta della casa editrice ha intonato “Bella ciao” al suo passaggio. Questo è il livello, inutile nasconderlo. Al salone hanno presentato i loro libri ex brigatisti del calibro (mai modo di dire fu più appropriato) di Renato Curcio e Adriana Faranda, non subendo alcuna censura e avendo una vetrina promozionale unica in Italia. Di contro, un autore autorevole come Marcello Veneziani, non è gradito a Torino da anni, come lui stesso scrive nel suo blog. Nemmeno questo però è sufficiente a spiegare il deragliamento del salone di quest’anno, la totale faziosità e illiberalità di una piazza che più che globale sembra comunista, molto simile alla fiera del libro di Lipsia nella Germania dell’Est di un tempo. Infatti, uno dei consulenti del salone, Christian Raimo che definisce il salone “militante antifascista”, ha fatto una vera e propria lista di proscrizione, prima di dimettersi e “addolorare” il fazioso Lagioia. Raimo scrive così: Le idee neofasciste, sovraniste sono la base per l’ideologia della forza maggioritaria di governo. Poi, cita gli autori ed editori ai quali il salone dovrebbe essere proibito: Alessandro Giuli, già condirettore del “Foglio” e direttore di “Tempi”, oggi in tv su Raidue nella trasmissione Povera Patria; Francesco Borgonovo, vicedirettore de “La Verità”; Adriano Scianca, responsabile nazionale della cultura per CasaPound Italia; l’editore Francesco Giubilei di “Historica-Giubilei Regnani” e rincara: Tutti i giorni in tv, sui giornali, con i loro libri sostengono un razzismo esplicito e formano think tank organici con il governo. Pure allo scrittore e saggista Pietrangelo Buttafuoco, nota, “al Salone non darei tutto questo spazio”. Dopo queste esternazioni si scatena la bufera, insorgono in tanti e il salone accetta le dimissioni di Raimo. La realtà che emerge da tutto ciò è chiara, lampante: quelle dimissioni sono una pagliacciata ridicola e patetica. Altaforte viene bandita, l’autrice del libro su Salvini contestata e la lista di proscrizione, in fondo, li vede tutti d’accordo, anche se non lo dicono esplicitamente. Il salone è una manifestazione di editori e intellettuali di sinistra, dove il pensiero unico domina e chi non vi si adegua, in un modo o nell’altro, viene fatto fuori. Punto. Non occorre edulcorare la pillola, trovare giustificazioni di sorta quando è la cultura ad essere limitata nelle sue espressioni e la libertà d’opinione, in quel contesto, così fortemente compromessa. La fortuna di quest’epoca, almeno per ora, sono i blog (i social network molto meno) che ci consentono di scrivere e divulgare il nostro pensiero; lo è anche il self publishing su certe piattaforme (come quella di Besoz, appunto) che libera lo scrittore da molte catene ideologiche e contrattuali. Essere diversi, pensare in un altro modo, metterlo alla fine per iscritto, sono “colpe” che non vengono perdonate, ed io, nel mio piccolo, ne so qualcosa. Tuttavia, personalmente non mi piango addosso e non ne risento più di tanto, faccio mia una massima di Oriana Fallaci che mi guida e mi guiderà in questo percorso: Voglio essere tra quelli che muoiono senza avere mai avuto sulla fronte e sulla mano il marchio della servitù o della complicità. Non ci sono manifestazioni di parte, visioni illiberali e dittatoriali, roghi e violenze che mai siano riusciti né mai riusciranno a incatenare il pensiero umano. Un uomo lo puoi imprigionare, torturare, controllare, uccidere ma ciò che ha nella testa è solo suo e inviolabile. Sarebbe bello che gli organizzatori del salone di Torino comprendessero che le idee sopravvivono alle ideologie, li aiuterebbe a fare meno figure imbarazzanti a livello internazionale.
Terra rossa (Trieste, 26 febbraio 2019)
Avevo pensato erroneamente che la ricorrenza del Giorno del Ricordo di quest’anno rappresentasse un passo avanti, un’accettazione definitiva, almeno a livello istituzionale, di fatti storici che hanno angosciato gli esuli istriani per decenni nel totale oblio. Il discorso di Mattarella aveva fugato ogni dubbio sulla posizione italiana, in una sala del Quirinale piena di rappresentanti politici e istituzionali, inclusi gli ambasciatori di Slovenia e Croazia. Poi le parole enfatiche di Tajani a Basovizza, apparse subito come un azzardo, quel “viva l’Istria e la Dalmazia italiane”, mi avevano fatto intuire che potevano esserci delle strumentalizzazioni. Nulla di ciò che mi ero immaginata, però, si avvicina al putiferio scatenatosi nei giorni e addirittura nelle settimane successive. La Slovenia e la Croazia sono insorte, si è parlato di “rivendicazione territoriale”, di tradimento dello spirito europeo, di nuovo irredentismo, di fascismo, di imperdonabile provocazione, insomma roba da richiamare gli ambasciatori nello stile dell’isterico Macron. La stampa croata, che ho seguito in questo periodo, si è scatenata contro Tajani e Salvini (si sa, Salvini è sempre colpevole di qualcosa), sono volate parole grosse, insulti, qualcuno ha pensato di raccogliere firme per chiedere a Bruxelles la testa di Tajani. Esplicativi poi i commenti degli utenti dei social network agli articoli condivisi dai quotidiani croati, un susseguirsi di frasi nazionaliste inimmaginabili in Occidente, di insulti verso l’Italia e gli italiani, di attacchi feroci nei confronti del gruppo etnico italiano in Istria, di promesse di massacri qualora la nazione “fascista” avesse delle pretese sulle sacre terre croate, di offese nei confronti del governatore Flego, “colpevole” di portare un cognome italiano. Un continuo vomito di frasi razziste che, a quanto pare, se rivolte verso l’Italia non provocano alcuno sdegno. Il quotidiano “Glas Istre” ha intervistato un signore di Pola, un italiano che si definisce “garibaldino”, un sognatore che parla ancora di Mazzini. Mi ha fatto molta tenerezza, ho rivisto in lui me stessa, l’educazione ricevuta in una famiglia di idealisti che al pensiero mazziniano hanno sempre creduto, che hanno immaginato un’Italia unita e orgogliosa della sua storia, della sua grande cultura. Insomma, pochi sparuti idealisti totalmente fuori dal tempo e dalla realtà, traditi storicamente dalla “madre patria” e sbalzati in una situazione di emarginazione e oblio perenne. Non sono tardati ad arrivare gli insulti a questo signore, le minacce, il gergo volgare che i croati nazionalisti non ci hanno mai lesinato. Lo si invitava soprattutto ad andarsene, a lasciare la terra dove sono nati i suoi avi, ed erano in particolare i croati arrivati in Istria negli anni ’90 a suggerirglielo, con gergo primitivo. Il messaggio è sempre stato chiaro per altro, quando Tuđman fece il suo discorso a Buie, nel 1990, disse chiaramente che se gli italiani dell’Istria non erano d’accordo con la politica della futura Croazia indipendente, potevano prepararsi ad un secondo esodo. La mia famiglia non se lo fece dire due volte, nello stesso anno eravamo a Trieste, e mai ci siamo pentiti di essercene andati, pur non avendo trovato nell’Italia la patria che speravamo. Qualcuno ha provato a difendere questo signore, qualche morlacco (i morlacchi sono slavi istriani presenti sul territorio da secoli) ha fatto dell’ironia, ridicolizzando i nazionalisti, però a poco è servito. L’Istria è perduta da tempo e non mi riferisco alle rivendicazioni territoriali italiane, per altro mai esistite. La mia regione è perduta nella barbarie, nell’ignoranza, nelle mistificazioni storiche, nelle offese ai paesaggi, nella convivenza civile disintegrata per sempre, nelle fauci degli amministratori locali avidi e corrotti, nella rassegnazione ad essere finiti così in basso. La terra rossa che ho calpestato nella mia infanzia, che mio padre ha coltivato per tutta la vita, che ha dato le fondamenta alla casa a fine paese, distaccata da tutte le altre, come se i miei avi avessero intuito la nostra diversità, non mi appartiene e forse non mi è mai appartenuta.
Sono nata poco prima del Trattato di Osimo, trattato nel quale l’Italia dimostrava anche formalmente il suo disinteresse per noi, in una Jugoslavia in crisi, anche se nessuno lo diceva, in una nazione dove noi eravamo decisamente poco graditi. Da quando c’è la Croazia, dopo la dissoluzione di quella nazione costruita senza fondamenta e su base ideologica, la nostra presenza è anche meno gradita. Siamo il ricordo di un passato finito, concluso, cancellato dai loro libri di storia, però ben visibile nell’architettura, nei siti storico-archeologici, nelle tradizioni, nella cucina, nei toponimi autentici, nei registri dei secoli addietro, nella parlata che ancora sopravvive. Ai croati sembra logico e plausibile negare che i secoli della Serenissima si possano considerare “italiani”, invece la presenza della Croazia dal 1991 ha radici storiche profonde. Nulla di strano, comunque, considerando che si vuol far passare Marco Polo per croato. Tutto ciò può sembrare stupido e ridicolo, visto soprattutto dalla prospettiva italiana che non ha alcuna ambizione nazionalistica né in Istria né altrove. L’Italia è senza dubbio il paese più esterofilo e meno nazionalista di tutta Europa, questo gli sloveni e i croati lo sanno bene, però fingono di subire aggressioni inesistenti e fanno gli indignati. La Croazia, dall’alto del suo nazionalismo, pare però poco interessata agli aspetti pratici che riguardano i suoi cittadini, mi riferisco al fatto che sia realmente una terra di conquista, non certamente per la nazione italiana ma per i suoi imprenditori rampanti. Delocalizzare in Croazia può essere un vantaggio, non appetibile come la Serbia ad esempio, però sicuramente accettabile per chi desideri pagare meno imposte, salari come minimo dimezzati (in Croazia si lavora nelle fabbriche per 500-600 euro al mese), pochi controlli e ancora meno restrizioni ambientali. Dalle mie parti poi sorgono agriturismi e case vacanza ovunque, neanche a dire i clienti più ambiti sono gli italiani, ovvero i turisti che spendono in modo molto diverso rispetto ai parsimoniosi tedeschi; eppure l’italiano viene visto come un essere fastidioso, da ridicolizzare e fregare possibilmente, mentre al tedesco si deve portare rispetto. Per i proprietari di alcuni di questi locali, i tagliani sono gentaglia, imbecilli da spennare, persone di cui vergognarsi. Certo, i loro soldi fanno gola e fanno comodo, ma solo perché non se ne può fare a meno. Sono convinta che la maggior parte degli avventori triestini, veneti e di altre regioni che qui si recano, sanno perfettamente cosa i croati pensano di loro, ma al solito l’italiano crede di meritarsi tutto il peggio del mondo e di dover anche ringraziare per la scortesia. Da tempo sento di dovermi allontanare da tutto ciò, di dover guardare altrove, di dover abbandonare per sempre quella terra rossa che ha visto i miei primi passi e che mio padre tanto amava. Se non lo faccio è per un motivo, uno solo: so che la mia presenza dà fastidio, so che dà fastidio ciò che scrivo su queste pagine e su quelle dei libri, e questo mi piace molto. Dare fastidio è l’unico motivo per cui sono legata alla terra e ai muretti di Stridone, alla mia vecchia casa, a quel campanile veneto che osserva silenzioso l’imbarbarimento costante. La mia mente da tempo vaga nelle terre del Nord, tra i fiordi norvegesi, nei ghiacci eterni, nelle città colorate che si specchiano su acque cristalline; lì, nelle terre e nei mari dei vichinghi, dove la vita dura ha insegnato al miglior popolo d’Europa il rispetto per l’altro, la solidarietà, l’amore per la natura e per la propria stirpe, vorrei trasferirmi per non tornare più indietro. Paolo Diacono nella sua Storia dei Longobardi diceva che tanto più è lontana dal sole e gelida per il freddo una regione, tanto più sono salubri le stirpi; come al contrario le regioni più temperate, più gradevoli, creano stirpi più deboli. Il Mediterraneo ha visto sorgere le più grandi civiltà di tutti i tempi, ci ha dato purtroppo anche il modo di avere tempo da perdere in dispute inutili. La terra rossa è lontana, una lontananza ormai siderale, anche se la porto nel cuore; la vita è altrove, in altre dimensioni e con altri interlocutori. Per fortuna.
Una scomoda tragedia (Trieste, 10 febbraio 2019)
Venerdì scorso Rai Tre ha mandato in onda il film Red Land (Rosso Istria) di Maximiliano Hernando Bruno, in prima serata. Una scelta del tutto logica, visto che sulla locandina del film appare il logo di RaiCinema e la Repubblica italiana ha istituito il Giorno del Ricordo mediante una legge. Una scelta anche molto “sapiente”, dal punto di vista dell’intellighenzia dominante, essendoci sulla prima rete il Festival di Sanremo. L’idea, a pensar male, era quella di azzerare gli ascolti per questo film così scomodo e coraggioso, in grado di strappare la coltre di vergognoso silenzio calato sulla tragedia istriana, anche nel sommo tempio della sinistra: l’arte cinematografica. Evitando di trasmetterlo oggi, il 10 febbraio, a Festival concluso, il film doveva passare del tutto inosservato. Pare però che le previsioni siano state disattese, Red Land ha ottenuto maggiori spettatori del seguito programma Propaganda Live, su LA7. Poi il discorso del Presidente Mattarella, durante le celebrazioni della ricorrenza presso il Quirinale, ha chiarito una volta per tutte e in modo inequivocabile la sua posizione e quella dell’Italia: le foibe non furono una ritorsione contro i torti del fascismo, come qualche presunto storico negazionista ha insinuato, erano un’espressione di puro odio anche verso persone che col fascismo non c’entravano niente. Dal punto di vista ufficiale, dunque, quest’anno le celebrazioni hanno seguito una linea chiara e diversa da quella dell’anno scorso, quando mi sono vergognata di vivere in Italia. Oggi alla foiba di Basovizza la presenza del vice premier Salvini e del presidente del Parlamento europeo Tajani, hanno portato alle vittime delle foibe e ai loro familiari il supporto delle istituzioni italiane e dell’Europa. Tutto bene, insomma. Purtroppo non è così, gli aspetti ufficiali non si traducono in una vera comprensione e condivisione in questo paese, anzi. Non solo gli “storici” negazionisti, ma anche molte persone appartenenti alla sinistra (e non solo a quella radicale) si sentono di scrivere con convinzione che la tragedia degli istriani è una pura conseguenza del fascismo di confine, che Norma Cossetto (raccontata nel film) era una fascista e che, dopotutto, questi fatti non andrebbero ricordati. La fascinazione per i regimi totalitari di sinistra, nell’Europa occidentale, non è mai cessata, men che meno in Italia dove all’ideologia si aggiunge anche un masochismo storico nei confronti di se stessi: tutto ciò che capita agli italiani è meritato, parola degli italiani stessi. Le foibe sono state un argomento tabù almeno fino alla fine della Guerra Fredda, così com’erano poco noti i gulag, i killing fields, le purghe staliniane e tutta una serie di nefandezze compiute dai regimi comunisti nel mondo. Poi non tocchiamo Cuba a questi “rivoluzionari” occidentali nei loro salotti, per carità! Venissero a conoscenza delle violenze subite dal poeta Reinaldo Arenas potrebbero restarci male, oppure, più probabilmente, fregarsene e tacere, tacere sempre. Il silenzio è l’arma usata per decenni: ignorare i fatti, non raccontarli, non menzionarli nemmeno. Il giornalista Enzo Biagi scrisse la storia della seconda guerra mondiale nel 1993, dove parlando di Trieste e del confine orientale non menziona nemmeno le foibe e l’esodo, come se non ci fossero stati. Questo era l’ordine, il credo, la filosofia: non parlarne, mai. Oggi non è più così, qualcuno ne ha parlato, la Repubblica italiana non lo ignora, al monumento di Basovizza ci vanno ministri e presidenti, al Quirinale rendono omaggio alla tragedia anche gli ambasciatori di Slovenia e Croazia. Quindi che fare? Arrendersi e ammettere che i partigiani non sono stati tutti e sempre degli eroi? Ammettere che il comunismo a nefandezze non è secondo a nessuno? Quando mai! Se non si può più negare allora occorre mistificare. Le foibe sono conseguenza di qualcosa di peggio, Norma era fascista, i morti erano fascisti, Tito, come la si vuole vedere, era un liberatore. Così l’Anpi organizza delle contro-conferenze con personaggi quali la Kersevan e la Cernigoi, accusa tutti, a questo punto anche Mattarella, di raccontare balle e di fare a gara a chi la spara più grossa. Già, sparare. Il film Red Land mostra chiaramente gli spari da inizio film, quando gli animali selvatici fuggono nel bosco per via degli spari, all’ultima scena, quando i disgraziati davanti alla foiba sentono le ultime parole prima di precipitarvi dentro: metak foiba, metak foiba (proiettile foiba). Legati col filo spinato, uno moriva ucciso dal proiettile, l’altro precipitava nella cavità vivo. In Istria le foibe sono ovunque, il Carso ne è pieno, non mancavano gli inghiottitoi. Dopo il ’43 alcune di queste cavità sono state esplorate, molti cadaveri recuperati, incluso quello di Norma, seviziato in maniera indescrivibile. Ciò che accadde nella primavera del ’45, e anche dopo a guerra finita, quando operavano in tutta libertà l’OZNA (polizia politica di Tito che poi diventerà Udba) e i “tribunali del popolo”, si può facilmente immaginare. I miei genitori hanno vissuto quella fase, la gente che spariva, il terrore, le convocazioni, gli interrogatori; poi le espropriazioni, le “riforme” che imponevano un nuovo ordine totalitario, la miseria e la fame oltre ogni immaginazione, l’obbligo di lavorare per lo stato nella costruzione di strade e ferrovie, detto “volontario”, in realtà pura deportazione (mio padre ne sapeva qualcosa), il divieto di insegnare e studiare in italiano, le chiese usate come magazzini, il vescovo di Zagabria trattato come un criminale. Delle foibe poi non si doveva parlare, né allora né dopo, non si dovevano nominare nemmeno per sbaglio o si finiva davvero male. Poi, a fine anni ’80, i settant’anni di marcia verso il nulla del comunismo mondiale erano giunti alla fine, la Jugoslavia era giunta alla fine, e l’abisso della guerra civile era prossimo. Il timore era che l’Italia si ricordasse della sua storia, delle terre regalate col Trattato di Osimo, degli esuli silenziosi che hanno lasciato parenti e congiunti nelle foibe, insomma nel timore che qualcuno iniziasse ad indagare si presero delle decisioni in merito. Si pensò di recuperare le ossa umane da molte di queste cavità, mandando gli speleologi fedeli al regime morente a fare il lavoro, documentando con delle riprese. No, non è un’invenzione come direbbe la Kersevan, non è una balla come vorrebbe l’Anpi: ho visto uno di quei video, realizzato da un vicino di casa incaricato di fare il “lavoro”. Il fatto che sapessero in quali foibe andare, tra le migliaia che ci sono, indica che gli eventi erano noti e anche i luoghi. Molte foibe furono chiuse da gettate di cemento, molte saltarono in aria. La Jugoslavia ovviamente sbagliava credendo che all’Italia e soprattutto agli italiani importasse qualcosa, eppure nel dubbio non si fecero cogliere impreparati. In questo modo ora chiunque può dire: “andate nelle foibe, vediamo quante ossa recuperate”. Tornando al film che racconta una vicenda all’interno di una vicenda ben più grande, il merito del regista e del cast è la mancanza di sconti di pena, del politicamente corretto, del “però gli italiani fecero…” che tanto piace ai “salottari” con la verità in tasca. Ho letto commenti disgustosi ovunque riguardo a questo film, attacchi al regista, insulti verso il bravissimo attore sloveno Romeo Grebenšek che ha interpretato un difficile ruolo, verso i produttori, verso tutti insomma. Una rabbia cupa e folle, un odio talmente vivo che sembra non sia passata nemmeno una settimana da allora. Il commento più disgustoso che ho letto, però, viene da una donna della minoranza italiana in Istria, una donna che ha anche un ruolo. Lei è rimasta colpita, offesa, da una parola detta proprio da Grebenšek, quando nel ruolo del capo partigiano Mate, dice “s’ciavi” riferito agli slavi, il modo con cui venivano apostrofati con disprezzo dagli italiani, ma l’avrebbero pagata cara. Siccome a Trieste è abitudine definire così chi viene da oltre confine (l’hanno detto spesso anche a me e non ne sono stata felice) e anche a questa donna a quanto pare, quando studiava qui, per lei quello è un demerito del film e la parte che l’ha offesa. Che sia ben chiaro, lo stupro di gruppo subito da Norma (17 aguzzini, per giorni) e la sua fine nella foiba, gettata ancora viva, non le hanno fatto effetto. I miei genitori non hanno mai voluto iscriversi nei circoli italiani in Istria, non fino a quando c’era la Jugoslavia, non fino a quando la bandiera italiana era sporcata dalla stella rossa nel mezzo e non fino a quando il busto di Tito troneggiava in quelle sedi: sono grata ai miei genitori per questo, non hanno voluto che mi mescolassi a nessuno e oggi il termine s’ciava a me non fa alcun effetto.
Un’estate lontana (Trieste, 19 agosto 2018)
Mi è toccato un triste compito in questo mese di agosto, pochi giorni prima del mio compleanno. Ho raccolto i vestiti, gli oggetti, i ricordi di mio padre dalla nostra casa di campagna, a Stridone, in Istria. Un compito doloroso per una figlia, a nove mesi dalla perdita del padre. Mi sono ritrovata nella stanza dei miei genitori, dove da piccola dormivo su un lettino. Una stanza non molto grande, con una finestrella che dà sul pergolato davanti a casa. Le pareti intonacate di bianco, i mobili anni Settanta scelti con gusto, la specchiera sotto la quale mia madre teneva l’acqua di colonia, l’unico vezzo della sua femminilità sacrificata al lavoro e alla famiglia. Poi, nel comodino di mio padre, ho ritrovato delle fotografie, ritraggono noi della famiglia, qualche parente, qualche amico. In mezzo ai ricordi ecco spiccare una foto del 1969, con mio fratello di un anno, due parenti e loro, i miei genitori. Ho visto mio padre bello come un attore, trentacinque anni, camicia e pantaloni leggeri cuciti probabilmente da lui. L’ho visto felice, innamorato di mia madre e del suo bambino che cresceva sano. Sono nata anni dopo, tra le foto ci sono anche quelle del mio battesimo, ma è quest’immagine di un’estate lontana, intrisa di serenità e di gioia, scattata a due passi da casa, che mi ha toccato il cuore. Era un’Istria povera quella degli anni Sessanta, assomigliava alle colonie africane più che ad un paese occidentale: la luce era arrivata soltanto nel 1966, l’acqua corrente alla fine del decennio successivo, occorreva infatti avere i pozzi. Eppure loro mi sembravano felici, appagati. La vita durissima di mio padre era costellata da mille episodi dolorosi e difficili. La prima infanzia durante la guerra, a soffrire la fame, resa più crudele dalla morte di suo fratello maggiore sul Don; il militare in Jugoslavia, altra fame e il rischio di finire fucilato per una banale battuta su Tito; la vita indigente in quel paese di poche anime e di troppi rancori; la sua fine, una brutale malattia che lo ha allontanato dal mondo e dai suoi affetti. Era un uomo generoso mio padre, proprio perché la vita non gli ha risparmiato alcuna tribolazione: aiutava senza pretendere nulla in cambio. Non si sarebbe infatti stupito se avesse saputo che alcuni che lo chiamavano ipocritamente “zio” e “santolo” non fossero mai andati a trovarlo durante la sua lunga degenza, non fossero venuti nemmeno al suo funerale, non avessero fatto neanche quella minima telefonata di condoglianze a mia madre. Mio padre sapeva in che mondo viveva, gli era ben chiaro come il bene che aveva fatto fosse stato dimenticato con facilità, ma sapeva anche che la malvagità ricevuta doveva necessariamente scorrere via, bisognava impedirle con ogni mezzo di inquinare la vita. Vorrei essere come lui, fatalista senza sconfinare nel cinismo. Guardando la foto mi accorgo che il male del mondo non turbava l’espressione di mio padre, anzi lo spronava a ricercare la felicità. Il ricordo di un’estate lontana ora è una gemma che custodisco nella memoria, sarà la luce nel percorso difficile che il resto della vita mi riserva.
La fine di un’era (Trieste, 06 giugno 2018)
Philip Roth ci ha lasciato da poco, la sua dipartita ha riempito le pagine dei giornali e tempestato di servizi i telegiornali. Lo hanno ricordato in tanti, elogiando il suo stile e la sua inventiva così originali e fuori dagli schemi. Roth ha scandalizzato il mondo della sua epoca con romanzi che hanno caratterizzato un’intera generazione in rivolta, stanca di quel senso puritano, oppressivo e moralista imposto al comportamento pubblico che nascondeva, dietro un’ipocrisia insopportabile, i bisogni e le fragilità dell’essere umano. Nel celeberrimo “Lamento di Portnoy” Roth mescola abilmente, attraverso un linguaggio esplicitamente “scandaloso”, la tragedia e la commedia, tracciando il ritratto di un giovane ossessionato dalle pulsioni sessuali, raccontate sul lettino dello psicanalista: una rappresentazione efficace e per niente consolatoria di un’America borghese e confusa. Da questo grande successo, foriero di polemiche a non finire di cui l’autore non si è curato più di tanto, si arriva – passando per molti altri libri – al Premio Pulitzer vinto con il capolavoro “Pastorale americana” nel 1998. L’alter ego dell’autore, Nathan Zuckerman, racconta la storia dell’americano di successo a cui il destino si rivolta contro, colpendolo nel punto dove gli fa più male: la figlia deviata che lo trascina negli inferi. Le vite dei protagonisti implodono con sullo sfondo lo scandalo Watergate, segnando l’unione del privato e del pubblico nel medesimo fallimento generazionale. Ed è in questo periodo, alla fine degli anni Novanta, che Roth diventa per me un simbolo, un autore da seguire e da cui imparare. Non semplicemente un maestro, bensì una persona che ho sentito vicina nei momenti di rabbia e confusione; un autore che parlava anche di me tra le sue pagine, aiutandomi a superare le crisi. Ho amato il Roth della maturità, nei suoi romanzi meno “politici” se vogliamo, più inclini ad analizzare i turbamenti dell’animo umano, nella sua dimensione privata. La politica è sempre presente nelle pagine dell’autore, però con l’abilità di essere sfumata dando spazio alla riflessione intima. Mi ha sempre colpito la sua data di nascita, legata per coincidenza (o forse qualcosa di più?) alla mia storia personale. Philip Roth nasce a Newark, nel New Jersey, il 19 marzo 1933, figlio di immigrati galiziani di religione ebraica. Quale legame dunque con la mia vita, così distante geograficamente e culturalmente? Mio padre è il legame: nato in Istria il 26 marzo 1933, figlio di contadini con poche o nessuna speranza per il futuro. Eppure ho intravvisto spesso tra le pagine del grande scrittore, l’anima di mio padre e di tutta la loro generazione. In modi diversi, si intende, hanno cercato entrambi di mettere in discussione regole e consuetudini della loro vita, ricercando vie alternative, pensando in modo diverso. Il grande Roth ha offerto le sue efficaci riflessioni al mondo, attraverso la sua abilità di narratore; mio padre ha offerto a me, la figlia “deviata” che non ha mai messo bombe o ucciso ma che è sempre stata diversa quanto la gramigna in un campo di girasoli, la sua comprensione e la sua riflessione riguardo a regole sociali che nemmeno lui comprendeva. Proprio qui, in questa rubrica di riflessioni, ho parlato di Philip Roth e di mio padre, tempo fa, pensando ad uno dei romanzi che più mi hanno segnata: “Everyman”. Era la fase più dura della malattia che ha ucciso mio padre, torturandolo impietosamente fino alla fine. Allora mi venne in mente il durissimo libro di Roth, le sue riflessioni sulla morte e sull’impotenza: uno schiaffo feroce di realtà datomi dalla mano del grande autore americano, “gemello” diverso di mio padre, che raccontava la fine tanto vicina ad entrambi. Non ho più mio padre da dicembre, ora non ho più nemmeno l’uomo che idealmente mi legava a lui. La fine di un’epoca è giunta, sia a livello generale con la fine dei grandi autori epici, che a livello personale e privato. Come nella sua “Pastorale americana”, Roth mi racconta la mia realtà di essere umano inserito in un grande contesto di cui stento a comprendere i meccanismi. Ciò che ho imparato da lui e da mio padre è però fondamentale, incisivo, fatale: le regole mi condurranno alla morte, e se non avrò la forza e il coraggio di cambiarle, la vita dall’inizio ad allora non avrà avuto alcun senso.
Un cattivo ricordo (Trieste 16 febbraio 2018)
Per molti anni ho partecipato in quanto autrice al Giorno del Ricordo, dedicato ai martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Pur essendo discendente dei cosiddetti “rimasti” in terra istriana, la mia voce ha avuto credito tra gli esuli e tra le istituzioni che mi hanno invitata a Udine e per diversi anni a San Vito al Tagliamento. In quelle occasioni ho portato i miei libri che si legavano al tema (Libera, una storia istriana e Dove danzavano le streghe) e numerosi recital quali Angelina, La promessa sposa e Tomizza, un istriano della conciliazione a testimonianza di una tragedia che ha colpito la mia gente ed ha conseguenze tuttora sulla vita di tutti noi. Mi era sembrato che ci fosse empatia per il nostro dramma, che la giornata non fosse una mera finzione ma che suscitasse una qualche riflessione. Ci sono sempre stati i negazionisti, coloro che sbraitano e urlano contro gli istriani, però sembravano voci isolate. Quest’anno invece tutto è apparso diverso. Siamo in prossimità delle elezioni politiche di marzo e così, come niente fosse, la tragedia della mia terra è diventata il pretesto per scontri e offese assurde, sulla pelle dei morti e dei loro discendenti. A Macerata al corteo anti fascista, anti razzista, anti leghista e chi più ne ha più ne metta, si sono levati cori del tipo “ma che belle son le foibe da Trieste in giù”. A Torino, sempre al corteo anti fascista, sono state lanciate bottiglie e bombe carta in prossimità dei quartieri degli esuli. A Modena è apparso lo striscione “Maresciallo siamo con te, meno male che Tito c’è”. Questo solo per citare alcune simpatiche manifestazioni di affetto nei confronti degli istriani, usati come pretesto per attaccare le formazioni di destra. Molti esuli si sono chiesti, con amarezza, per quale motivo l’Italia ha istituito questa giornata dopo sessant’anni di oblio per poi consentire alla piazza di urlare la sua rabbiosa ignoranza? Perché non lasciare la nostra tragedia nel dimenticatoio senza fare tante inutili cerimonie, come quella al Senato? Le piazze urlanti, i manifesti e gli insulti non sono stati condannati da nessuno, si sono fatti passare per fatti isolati di “cattivo gusto”. Sono nipote di un uomo proveniente da una famiglia italiana, istriana e antifascista, una famiglia che non amava il Duce e le istituzioni di quel periodo, eppure mio nonno Costantino doveva finire dentro una foiba, solo perché si era permesso di recarsi a Portole (sede del presidio fascista) per lavoro ed aveva portato con sé la sua famiglia. Stessa sorte doveva toccare a sua sorella, la prozia Libera, donna coriacea e senza paure, una forza della natura che si sarebbe fatta ammazzare pur di non smentire se stessa. Si sono salvati grazie ad una capo partigiano, amico di famiglia, che accortosi dei loro nomi, li aveva tolti e aveva minacciato di morte chi ce li aveva messi. Si chiamava Gabriel, era di un paese vicino al nostro, ed io non mi chiamo Gabriella casualmente. Condivido qui la foto di Libera, nel suo splendore vintage, in ricordo del libro che le ho dedicato. La condivido anche per esprimere il mio giudizio su questa faccenda, riguardo il Giorno del Ricordo: noi istriani non abbiamo bisogno di una legge fatta da una matrigna baldracca, una cloaca di mezzi uomini capaci di utilizzare la morte, il dolore e la disperazione per fini elettorali o per pestare i poliziotti.
Perché non mi regali un libro? (Trieste 17 ottobre 2017)
Capita ahimè a tutti gli autori, in molte occasioni, da ogni tipo di persona, di dover rispondere educatamente (anche se costa fatica) alla seguente richiesta fastidiosa e offensiva: “Mi regali un tuo libro?”. Un po’ come se ci recassimo in pizzeria e pretendessimo di mangiare gratis, perché in fondo facciamo un onore al ristoratore con la nostra sfolgorante presenza. Non è così vero? Non lo avete mai fatto scommetto. Certo, chi si sognerebbe di mangiare gratis, di andare al cinema o a teatro senza pagare? Nessuno ovviamente. Diverso invece è l’atteggiamento verso gli scrittori, specie se non famosi e desiderosi di ampliare il proprio pubblico. Chiedere un libro gratis è pratica comune, anzi, chiedere anche una decina di libri gratis è pratica comune. Sì, proprio così. Capita che gli organizzatori di diverse manifestazioni culturali dove si viene invitati gratis, bontà loro, chiedano un certo numero di libri – da regalare poi ai loro amici, facendo gli splendidi -in cambio della “grande vetrina” che ti offrono, con niente meno che un trafiletto sul giornale. La responsabilità di festival letterari, manifestazioni culturali, presentazioni di libri totalmente gratuite è responsabilità di tutti: editori, organizzatori e autori. Sì, perché andare a tutti questi eventi gratis, lavorando gratis, senza chiedere o ottenere nemmeno il rimborso delle spese di viaggio, fa sì che il lavoro dello scrittore sia talmente svilito e umiliato da non meritare nemmeno l’acquisto dell’opera che gli è costato fatica scrivere e pubblicare. Vogliamo parlare poi dei premi letterari che spuntano come funghi, non prevedono nessun premio in denaro e non costano niente a chi li organizza? Sono eventi che non hanno alcuna risonanza mediatica, nessun ufficio stampa, nessuno ne parlerà mai, ma il povero autore li inserisce nel suo curriculum quasi fosse il premio Strega. Nei dieci anni che ho trascorso a scrivere i miei dieci libri, decine di racconti, molti testi teatrali, le volte in cui mi è stato chiesto di donare il libro al giornalista di turno, all’organizzatore avido, al critico letterario logorroico e inconcludente, non si contano. Ammetto di esserci cascata anch’io nella trappola della “grande vetrina”, partecipando gratuitamente a molti eventi; purtroppo scrivendo anche tanto, sia racconti che testi teatrali, per i quali non sono mai stata pagata e, in un’occasione, dovendo anche assistere all’attribuzione del mio lavoro ad un’altra persona. Sono esperienze amare che possono avvilire così tanto una persona da portarla a lasciar perdere ogni possibile ambizione. Perciò va chiarito, sottolineato, ripetuto costantemente che questi eventi, queste collaborazioni gratuite, non portano assolutamente a niente. La gratuità è sinonimo di bassa qualità, come ho sentito dire sulla pagina Facebook di Bookblister. Sono parole sante queste, sono il Verbo per gli scrittori. La gratuità fa si che il pubblico partecipi ad eventi di questo genere perché non ha niente di meglio da fare, porta ad annoiarsi, a visitare gli stand delle fiere sbadigliando e, soprattutto, non comprando alcunché. L’unico modo per vendere un libro è la sapiente sponsorizzazione, la pubblicità sui media: insomma, occorre che l’editore spenda del denaro per la promozione. Non fatico a dire che i miei libri di maggiore successo non sono i migliori, sono quelli più commerciali distribuiti con i quotidiani di mezza Italia, talmente ben distribuiti che anche in termini economici non mi posso lamentare. Esiste un maggior incentivo del riscontro economico per un autore? Fidatevi, non esiste. La recensione positiva non significa niente, anzi. Un mio libro di grande successo, andato esaurito in breve tempo, Miti e misteri del Friuli Venezia Giulia, sputtanato pesantemente da un’autrice concorrente (la cattiva pubblicità è in assoluto la migliore perché genera curiosità) e osteggiato in tutti i modi dall’intellighenzia locale, è tuttora uno dei libri di maggior successo.
Non i libri di qualità come Libera. Una storia istriana o La guerra di Giusto che non hanno avuto alcuna visibilità mediatica ma che mi sono costati fatica scrivere e presentare al pubblico (gratis, ovvio); no, i libri che hanno venduto e anche tanto, sono le guide storico-artistiche, culinarie, folcloristiche che i quotidiani del gruppo Espresso hanno sponsorizzato e distribuito egregiamente e che, udite udite, non mi sono mai scomodata di presentare in nessuna libreria o circolo culturale. Tutto ciò, la mia esperienza decennale, descritta or ora brevemente sul mio sito, spero possa essere utile ai giovani autori che si affacciano in questo difficile ambiente. Occorre puntare alla qualità della distribuzione e non serve a niente, tranne ad auto infliggersi un’umiliazione, lavorare gratis per chi ti promette una “grande vetrina” o tanto meno regalare i propri libri per ottenere una buona recensione.
Da quale pulpito (Trieste, 10 gennaio 2017)
In questo inizio anno abbiamo tutti la sensazione funesta e sconfortante che i problemi globali, di geopolitica ed economici, siano sempre più marcati, privi di una vera strategia di risoluzione e pericolosamente intrecciati alle nostre vite quotidiane. L’ultimo attacco terroristico a Istanbul, appena a Capodanno, ci mette di fronte a quella sensazione di insicurezza costante che ci perseguita ormai giornalmente. A queste gravi problematiche si aggiunge il problema – anch’esso privo di una vera ed efficace soluzione – della massiccia immigrazione che è fortemente connesso a tutto il resto. Gli intellettuali, i tanti giornalisti fintamente pacati e politicamente corretti, gli amministratori della nostra politica che con le loro riflessioni sull’integrazione e l’accoglienza si riempiono la bocca e le pagine dei giornali, sono del tutto scollati dalla base della società, dai problemi reali. Nessuno di loro, ad esempio, prende come me gli autobus cittadini che attraversano le periferie e caricano decine di uomini, sui 20/30 anni, afghani o pakistani, che si “scontrano” in piccoli gesti di dicotomie essenziali del comportamento civile con la gente della mia città. Queste dicotomie, queste diversità, stanno diventando di giorno in giorno più stridenti, evidenti e creano un’insofferenza diffusa in tutti gli strati della popolazione: vecchi, giovani, operai che usano i mezzi pubblici per andare a lavoro, mamme con i bambini, disoccupati con pochi spicci per il biglietto. I cosiddetti richiedenti asilo non pagano per viaggiare, non lasciano spazio alle donne con le carrozzine, non agevolano gli anziani, guardano con indifferenza (se non con disprezzo) i lavoratori della Ferriera o le donne delle pulizie che vanno a lavoro con il bus per risparmiare sulla benzina e si spezzano la schiena, si rovinano la salute per salari ridicoli. Ma parlando di intellettuali che con tutto ciò non si confrontano, oggi rifletto sul pensiero di un illustre filosofo che ci ha lasciati: Zygmunt Bauman. Ebreo polacco, di formazione marxista, ha focalizzato le sue ricerche sociologiche e filosofiche – ad inizio carriera, si intende – sulla questione delle classi sociali e dei movimenti dei lavoratori. Poi decise di elevarsi da tutto ciò, dalle classi che si spezzano la schiena per poco (come detto sopra) e concentrò le ricerche sul concetto della modernità su scala globale, sui massimi sistemi insomma. Nobilissima e toccante fu la sua potente riflessione riguardante le connessioni di questa difficilmente definibile modernità con la tragedia dell’Olocausto, mentre le sue ricerche più recenti hanno esplorato la post-modernità con le sue infinite e soggettive implicazioni etiche. Di grande efficacia poi il concetto elaborato da Bauman di società liquida, questo mondo post-moderno appunto che trasforma i produttori in consumatori, dove la frenesia impone le regole del gruppo (o del gregge se vogliamo), genera paure e moltiplica paradossalmente le solitudini. L’attacco frontale alla globalizzazione è così completo, specie quando l’ossessiva omologazione al gruppo, ai valori da esso professati, Bauman arriva a definirla “omogeneizzazione”. Un neologismo per la filosofia che inquieta e incanta contemporaneamente, esplorato e spiegato da questo anziano pensatore che non si agitava mai negli incontri pubblici e non alzava la voce. Un uomo che ha dato un senso alla sua vita e al suo pensiero e che oggi tutti gli rendono merito. Ovviamente lo fanno gli intellettuali, i giornalisti, gli scrittori, molti politici che forse non l’hanno mai letto ma citandolo si danno un tono, ecc. Non di certo quella classe operaia di lavoratori (che ci sono eccome!) e che sono sempre più poveri, quei disoccupati lasciati a terra da una globalizzazione feroce e dalla conseguente mancanza di regole nel mercato, più che dagli effetti dell’omologazione, o omogeneizzazione come diceva Bauman. Sicuramente tanti giovani studiosi di filosofia si sono formati con i suoi scritti, con la sua visione, con quella tentazione di rivalutare sempre e comunque il marxismo trapassato. Me ne viene in mente uno in particolare, un giovane che conobbi (lui mi snobbò ovviamente) anni fa, quando fui invitata al Forum Tomizza organizzato dallo scrittore croato Milan Rakovac. Eravamo nel 2009, io ero entrata nel mondo dell’editoria da poco tempo e consideravo Fulvio Tomizza il mio unico grande maestro, per cui mi sentii onorata dalla possibilità di fare un intervento su di lui. Tra i tanti ospiti del Forum venuti da ogni parte della smembrata Jugoslavia e anche dall’estero che fecero lunghi ed estenuanti discorsi spesso fuori tema, nella sede della Comunità degli Italiani di Umago che porta proprio il nome dello scomparso scrittore istriano, fu invitato a parlare, come lo definirono, il “giovane filosofo e semiologo” Srećko Horvat. Un giovane dalla faccia pulita e dall’espressione arrogante che non degnò nessuno di uno sguardo, puntò al suo “pulpito” con microfono, e si gettò con impeto nella sua digressione personale senza bisogno di alcun appunto scritto. Il suo attacco era rivolto all’Italia, tanto per cambiare, in particolare al Governo Berlusconi che lui disprezzava apertamente. Ridicolizzò il Presidente del Consiglio italiano, i suoi ministri e le sue leggi, in particolare la legge sull’immigrazione. Disse che l’Italia è un paese razzista, una Nazione che lascia morire la gente nel Mediterraneo, quei poveri disperati che sfuggono dal controllo di Gheddafi (un tempo amico di Tito e membro dei “Paesi non allineati” ndr) a causa di leggi fasciste che evidentemente solo l’Italia poteva approvare. Trovai interessante il suo discorso, specie osservando che gli strali contro l’Italia si facevano in una sede delle tante CI in Istria finanziate con soldi italiani. Tutto, dalla struttura, alle poltrone, ai tavoli, al microfono dal quale il giovane Horvat lanciava insulti, era stato acquistato dal contribuente italiano e versato dal Governo tanto disprezzato. Quando finì con la veemente aggressione alla politica italiana, uscì dalla sala senza guardare nessuno e senza attendere applausi o eventuali contestazioni. Ci furono gli applausi, ma anche la critica del professor Ulderico Bernardi, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che trovò il suo intervento ingiusto e rivolto solo all’Italia. Ovviamente il Horvat non lo ascoltò, si era già allontanato sulle ali del suo pensiero superiore, di ispirazione marxista, affine a quello dello sloveno Slavoj Žižek, e sempre con il forte accento anti-italiano. Ora sono passati degli anni, sono accaduti fatti drammatici e sconvolgimenti epocali hanno scosso le nostre società. In Libia Gheddafi è stato ammazzato, il Paese bombardato da americani ed europei è precipitato nel caos, ed ha i porti belli e pronti per i trafficanti di esseri umani. Persino una parte del territorio è stata conquistata (poi ripresa dai governativi, di quale governo?) dai nuovi divi del terrore, gli uomini dell’Isis. La guerra in Siria, il caos furibondo e sanguinoso in Iraq, il disimpegno delle super potenze con truppe in campo ma interessate a spartirsi territori e ricchezze, hanno spinto migliaia e migliaia di persone verso il nostro mondo. Gente che fugge da guerre e persecuzioni, ma anche da miserie vecchie di decenni e che confluisce nel grande affare della tratta di uomini. Però negli ultimi anni non sono partiti solo dall’Africa questi uomini, questa volta no, hanno cercato di raggiungere la Germania e altri Paesi apparentemente disposti ad accoglierli passando per i Balcani. E cosa hanno fatto a questo punto i Balcani? I Balcani hanno investito denaro per costruire muri, blocchi, reti metalliche, filo spinato, sorveglianza militare anche con armamenti pesanti. Nemmeno nei tempi della Guerra Fredda o del cruento conflitto nei Balcani avevo visto le barricata ai valichi di confine mentre mi recavo a casa, in Istria: oggi ci sono ovunque e chiunque le può vedere. Ma torniamo ai profughi, alla gente che si muoveva a piedi perché ad un certo punto non gli si concedevano i mezzi di trasporto per ostacolarne le partenze: quando Frau Merkel tuonò che “ora basta” – e quando “basta” lo dicono i tedeschi è automaticamente legge -, per i Balcani non sono transitati più nemmeno le donne incinte ed i bambini non accompagnati. La rotta Balcanica si chiuse ed è ancora chiusa. Il nord Europa non vuole più nessuno e si danno soldi ai turchi purché se li tengano questi disperati. A distanza di poco più di anno da questi fatti chi accoglie oggi i profughi? Chi chiede almeno un barlume di distribuzione in Europa che il blocco dei Paesi dell’Est rifiuta? Che sia quell’Italia così razzista e fascista secondo il Horvat? Quella Nazione che oltre a comperare microfoni per gli strali altrui, costruisce sedi per la cultura e la scuola in Istria e Dalmazia, ma spende anche cifre consistenti per salvare e accogliere i disperati del Mediterraneo? Non solo, questa fascistissima Nazione deve pure tenersi gli afghani e pakistani sfuggiti ai muri e al filo spinato che Slovenia, Croazia, Austria ecc., fanno sì che varchino i confini e vengano a Trieste, in Friuli, a ciondolare per strada e nelle mense gratuite, sugli autobus e nei centri cittadini, senza regole e senza remore. Mi piacerebbe tanto chiedere adesso all’illuminato Horvat di mettersi sul pulpito, con un microfono possibilmente non comprato con i soldi italiani, e di trovare una giustificazione etica al comportamento del suo Paese.
Così parlò Zarathustra 2.0
Nella seconda metà dell’Ottocento, in epoca di ardori positivisti che immaginavano un’umanità più umana per mezzo della tecnologia e la scienza, il grande filosofo Nietzsche attraverso il suo mago orientale Zarathustra vedeva oltre le apparenze dell’illusorio uomo nuovo, incatenato entro antichi meccanismi. Egli predicava il super-uomo, e in un celebre passo dell’eterno romanzo filosofico, sosteneva: “Vi scongiuro, fratelli, restate fedeli alla terra e non credete a quelli che vi parlano di sovraterrene speranze! Essi sono degli avvelenatori, che lo sappiano o no. Sono spregiatori della vita, moribondi ed essi stessi avvelenati, dei quali la terra è stanca: se ne vadano pure!”. La sua era una critica feroce nei confronti di tutti i sistemi filosofico-politici della sua era, con la forza delle sue teorie seducenti: la morte di Dio, l’oltre-uomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza. Per il suo Zarathustra tutti gli esseri umani si trovano in condizione d’uguaglianza di fronte al Dio unico del monoteismo o della filosofia; poco prima della morte di questo Dio tutti gli individui risultano uguali in quanto folla, gregge anonimo. Conseguentemente la morte di Dio è una possibilità d’espressione per il futuro superuomo. Una nuova alba, un nuovo inizio. Un’alba che oggi appare tanto lontana quanto sembra vicina la tenebra. Quest’era oscura, inquietante, questo magma incandescente che sta discendendo sulla terra e sulle civiltà, mi sembra rappresentato in modo eccellente, nella città simbolo della bellezza rinascimentale, Firenze, dal nero e funereo David di Michelangelo interpretato e realizzato dall’artista Massimo Barzagli. Un David abbattuto, gettato a terra nella polvere, calpestato dall’ignoranza che aleggia ovunque, dipinto di nero dalla morte dell’intelletto e dalla dipartita della dignità dell’uomo civile. La fine, la resa quasi senza combattere. La rinuncia alla Bellezza di cui Ernst Jünger parlava nel suo romanzo Sulle scogliere di marmo, in un disperato atto d’accusa verso il barbaro del ventesimo secolo che, nel ventunesimo, appare più deciso che mai a distruggere ogni cosa. Dio è davvero morto? Oppure è morta o sta morendo la nostra bistrattata civiltà con una lenta eutanasia auto-indotta? Il Foglio, nell’edizione del 17 luglio 2016, si chiede in un articolo di Stefano Cingolani a che ora tramonta l’occidente. Interessante l’immagine metaforica utilizzata da Paolo Mieli sul Corriere della Sera e citata ampiamente: l’Europa in fiamme come la foresta di Yellowstone che fu colpita nel 1988. Allora le autorità scelsero di lasciar fare alla natura che, come ha sempre fatto, eliminò le eccedenze, il sottobosco che alimentava le fiamme; i guardiani si limitarono a difendere gli esseri umani e gli alberi che avevano dato prova di resistenza. Gli animali avrebbero dovuto cavarsela da sé. Quindi se utilizziamo questa metafora, qualora i fuochi della ribellione non si spegnessero da soli per via di una pioggia, di un dono della natura, occorrerà difendere le strutture (ovvero le istituzioni) e lasciare che i tronchi dei vecchi partiti politici, a tratti secolarizzati, affrontino le fiamme per essere bonificati; loro e le piccole e grandi burocrazie che li sostengono. Alla fine dell’incendio naturale nella foresta sopravvisse il 64 per cento della riserva. Accadrebbe così anche alla nostra società? Dubito che alcun guru della carta stampata sia in grado di rispondere. Di fatto la realtà ci indica che l’incendio appare prossimo. La madre della Rivoluzione che ha cambiato l’uomo contemporaneo – la Francia -, in vari attacchi terroristici, ha perso 230 cittadini in un anno e mezzo, senza che il governo francese prendesse dei seri provvedimenti. Poco dopo i fatti di Parigi del novembre scorso, Monsieur le Président ha conferito in gran silenzio la Legion d’Onore al ministro dell’Interno saudita, il ministro di un Paese che non occorre nemmeno sottolineare quali implicazioni, più o meno evidenti, ha con la radicalizzazione islamica in occidente; fatto che ha talmente colpito l’attrice Sophie Marceau da farle dire, quando le volevano conferire lo stesso titolo, la seguente frase: “La Legion d’Onore? Se la tengano pure!”. Dare un riconoscimento figlio della Rivoluzione ad un individuo che ordina decapitazioni che senso può avere? Che se lo tengano, appunto. Ed eccoci ad un nuovo attentato, nella bellissima Nizza, proprio nel giorno che santifica quella Rivoluzione. Misure di sicurezza incerte, tagli dell’Europa e della nazione stessa alla polizia perché prima vengono le percentuali di crescita, ed un massacro che si dipana davanti alle riprese fai da te nell’era 2.0. Il giorno dopo la gente è attonita, sconvolta, spaventata. Poi qualcosa cambia. Dame eleganti, uomini in abiti sportivi, giovani e vecchi, bianchi e neri, gettano immondizie sul luogo dov’è morto l’attentatore e sputano con rabbia, con disperazione verso quel cumulo orrendo. Qualcosa che i francesi normalmente non avrebbero fatto. Poi, durante la commemorazione, 40 mila persone fischiano il governo, in un momento di angoscia rabbiosa, e l’incerto inno della Marsigliese si mescola alle lacrime, segnato dalle voci spezzate di un popolo schiaffeggiato e umiliato in maniera imperdonabile. Hai voglia a dire, mentendo, che erano i sostenitore di madame Le Pen o quattro hooligans scalmanati, appare più che evidente che la contestazione era immane. I media iniziano subito la loro narrazione, declinata dall’ideologia dominante che ci vuole tutti proni e pronti a perdonare, o peggio, a darci ogni colpa per qualsiasi attacco terroristico; una narrazione definita soprattutto da una monumentale ignoranza che lascia attoniti. La direttrice del Tg3 Bianca Berlinguer, dal cognome “storico”, il giorno dopo, durante una diretta, afferma che l’attacco è durato qualcosa come due ore (confondendo i due chilometri del percorso, suppongo, con due ore di tempo), lo dice e ridice, lo ribadisce senza pudore, scansando la chioma dagli occhi e togliendosi e rimettendosi gli occhiali di continuo, con fare da consumata intellettuale. Il suo interlocutore, giornalista ed esperto di questi temi Alberto Negri, visibilmente imbarazzato, non ha il coraggio di fermarla e di farla ragionare, forse per via del suo “storico” cognome. E poi giù, su tutti i canali, valanghe di notizie assurde date senza alcuna verifica, fino a definire la Promenade des Anglais il “viale degli angeli”, spero confondendolo con la Baia degli angeli, ma temo confondendo anglais con anges; e pensare che bastava consultare un minuto google. Poi, mentre la narrazione dell’orrore e del finto piagnisteo era ancora in corso, ecco il golpe farlocco in Turchia. Tutti in silenzio per ore – i politici -, mentre i giornalisti facevano fiorire ogni tipo di costrutto mentale in possibile scenario reale. Finita la farsa, ecco abbattersi la scure del Sultano, ecco venir fuori gli elenchi pronti da chissà quanto tempo per la sua “purga” di memoria staliniana. Si parla di 49 mila funzionari, dipendenti statali, insegnanti privati e pubblici, imam avversi, sospesi; migliaia di arresti, militari denudati, torturati e umiliati fino all’inverosimile, giudici della corte suprema arrestati nell’immediato. Si parla di impiccare i “cani” traditori, si chiede che l’America consegni l’avversario politico Gulen, si minacciano le donne turche che non indossano il velo: la Turchia di Ataturk totalmente cancellata, probabilmente per sempre. La reazione europea genuflessa agli interessi della Merkel, profughi in primis, per voce della Mogherini e altri burattini? “Cattivo cattivone Erdogan, eh no! Così non si fa cattivone. Se ripristini la pena di morte mica ti vogliamo tra i bambini dell’asilo Ue”. Certo, perché la pena di morte è l’unico problema, mica il fatto che arresta i giornalisti da anni, che reprime e sbatte in galera chiunque, persino il premio Nobel Pamuk, che sta castigando in modo atroce chi si è fatto manovrare per il ridicolo golpe e che sta epurando in modo vistoso tutta la nazione cacciando chiunque entri nelle maglie della sua infernale resa dei conti. Cosa conta se le donne turche verranno schiavizzate? L’importante che la Turchia, glorioso membro della Nato, si tenga i profughi e che continui a fare affari, in nome del sopra indicato punto di crescita in più.
L’ultimo gigante
Ero una bambina piccola, molto piccola, sul finire degli anni Settanta quando andavo a vedere la televisione a casa degli zii (che poi erano prozii) Italo, Libera e Clementina. A casa nostra la TV non c’era ancora ed io adoravo i cartoni animati giapponesi che la RAI trasmetteva nel pomeriggio. Vivere in Istria, nell’allora Jugoslavia, era complicato e difficile ma ancora non lo comprendevo. La vita di una bambina segue gli stessi ritmi in tutto il mondo, gli stessi interessi conditi dalla stessa felice ingenuità che successivamente, nella vita, diventa ricordo malinconico se non doloroso, data la consapevolezza di non poter più rivivere quella condizione. Certe volte però, durante le frequenti campagne elettorali italiane, i cartoni animati venivano sospesi per dare spazio alle tribune elettorali. Come già scrissi nel mio romanzo Libera, quel fiume di parole dette da uomini vecchi e distanti mi annoiavano, tanto che mi addormentavo vicino alla stufa. Capitava però che la foga di certi politici, la loro grande capacità dialettica, riuscissero a destare dal sopore anche una bimba di cinque anni. Non erano molti ma li ricordo ancora. Il comunista “gentile” Enrico Berlinguer, l’imponente “reazionario” Giorgio Almirante, il “divo” Giulio Andreotti e il più trasgressivo, il più stravagante e diverso di tutti, sempre con la sigaretta accesa e la voce rauca, Marco Pannella. Lo trovavo curioso e interessante, con una parlantina eccellente e con un italiano così bello e articolato che sarei stata ad ascoltarlo per ore. Non sapevo nulla allora delle sue battaglie: il divorzio, l’aborto, il femminismo, la liberalizzazione delle droghe leggere, gli scioperi della fame per protesta ecc., ciò che mi piaceva di quel “vecchietto” (i bambini sono terribili nell’appiccicare etichette agli adulti) era il sorriso strafottente e la risposta pronta. Poi gli anni sono passati anche per me ed ora che corrono via come inseguiti da un orco, ora che vivo da decenni in quel Paese che il leader dei Radicali voleva cambiare, ora che spesso penso di tornarmene da dove sono venuta, lui, il vecchietto dal sorriso strafottente, non c’è più. L’ultimo dei giganti della politica italiana (gli altri sono tutti morti da tempo) lascia dietro di sé uno stuolo di parvenue della politica urlanti e inconcludenti, onnipresenti sui mezzi di informazione dove dicono tutto e niente come fossero la stessa cosa. Nella prefazione che scrisse al libro di Andrea Valcarenghi “Underground a pugno chiuso!”, nel luglio del 1973 (guarda caso sono nata neanche un mese dopo), Marco Pannella firma quello che per molti è il suo testamento politico. Al “kompagno” scrittore Pannella non risparmia alcuna critica e non cela nessun elogio. Egli dice senza mezzi termini che disprezza le rivoluzioni quando queste, anche se scaturite da motivazioni più che condivisibili, si tramutano in sistemi di violenza verso gli sconfitti, verso gli ex oppressori. Perché chi aborrisce la violenza lo fa sempre, se è coerente, e non può giustificare la brutalità scaturita da altra brutalità. Dice anche, con un’umiltà che è solo dei grandi, degli irraggiungibili, che lui non ha mai scritto un libro, un saggio, che non ha pubblicato nulla perché queste cose non le sa fare e non ne è capace. Marco Pannella che si dice incapace di scrivere e lo fa senza alcuna finta umiltà da intellettuale arrogante. Socrate contemporaneo, solitario e agguerrito, avvelenato inutilmente per anni dalla cicuta dei sistemi oligarchici che tutto vogliono omologare o annientare. Leggendo e rileggendo le sue parole mi sono resa conto della sua grandezza, della sua intelligenza fine e sofisticata, della sua straordinaria umanità che non concede sconti a nessuna congrega o consorteria politico-culturale; mi sono resa conto come non mi era mai accaduto prima chi era Marco Pannella. Tempo fa ebbi modo di conoscere Ennio Di Francesco, autore del libro “Radicalmente sbirro”, dove racconta, tra le altre cose, il suo incontro con il leader radicale. Ennio è un uomo eccezionale e lo era anche allora, quando dovette arrestare Pannella nella sua battaglia per la liberalizzazione delle droghe leggere. La solidarietà del poliziotto che vedeva gli abissi più neri dell’umanità verso il politico che voleva cambiare le cose, non fu tollerata ed Ennio pagò quella scelta, così come accadde per le altre battaglie che il commissario fece nella sua carriera. Ma a conti fatti essere coerenti è l’essenza di ogni rivoluzione interiore, di ogni cambiamento radicale che si riflette sull’agire umano e ne determina le conseguenze. Questo riguarda chiunque credo e Marco Pannella, in tale contesto, era un rivoluzionario autentico, di fatto l’ultimo leone indomito della politica italiana.
La sposa del deserto (Trieste, 30/03/2016)
Palmira, “la sposa del deserto” è stata liberata. Liberata dai bombardamenti russi, dalle truppe di Assad, dagli strateghi che preparano e perpetrano le offensive militari. Quando fu presa e “stuprata” l’anno scorso dalle truppe vestite di nero, quando l’archeologo ottantaduenne Khaled Asaad divenne un martire contemporaneo della Cultura, tutti siamo stati in qualche modo sconfitti. A distanza di secoli nei quali anche il nostro mondo si è tristemente impegnato nella distruzione dei beni culturali, a distanza di settant’anni da quando i liberatori d’Italia bombardarono impietosamente l’Abbazia di Montecassino e di pochi decenni dalla distruzione del Ponte di Mostar o dei Buddha in Afghanistan, la nostra civiltà, per l’ennesima volta, non è stata in grado di difendere ciò che di più prezioso l’uomo ha prodotto. I nostri governi sono stati capaci di mobilitarsi e di spendere fiumi di denaro per le più disparate motivazioni, bombardando e invadendo nazioni altrui; i mezzi d’informazione li hanno seguiti costruendo campagne mediatiche gigantesche e milioni di cittadini continuano ad essere terrorizzati dalle medesime campagne che ci fanno sentire perennemente insicuri dentro casa nostra. Sarebbe da porsi un quesito però, al di là di tutto, oltre la paura e l’incertezza dei tempi che viviamo. Per cosa vale ancora la pena rischiare? Di sicuro il professor Khaled Asaad si è posto questa domanda, quando tutti scappavano da Palmira e abbandonavano gli scavi e la città, quando molti reperti d’importanza assoluta furono in fretta e furia portati via, quando la sua stessa famiglia si mise in salvo in altre zone. L’anziano studioso non lasciò il sito archeologico che aveva amministrato per decenni, accogliendo milioni di visitatori: dai personaggi illustri che lo visitavano nella magia dei tramonti alle masse di turisti che vi si recavano con i pullman. Lui scelse di sacrificare se stesso per difendere la Bellezza, per ribellarsi alla furia cieca di una visione religiosa oscurantista che, con metodologie moderne, voleva distruggere la dignità di quel luogo. Ed ecco che nel mio piccolo desidero rivivere la Storia raccontando Palmira, la meravigliosa sposa del deserto sorta tra i palmeti di un’oasi. La sua magnificenza sorse a metà strada tra il Mediterraneo e l’Eufrate, le sorgenti dell’oasi che la videro nascere, la sua acqua benefica, permise alle carovane la traversata desertica per la via più breve dal medio Eufrate a Damasco. Fu menzionata la prima volta con il nome di Tadmor, forse datole da una tribù araba che vi si stabilì. In epoca ellenistica Palmira venne a contatto con lo stato seleucidico che aveva stabilito una colonia macedonica a Dura. Un documento certo della sua storia ci porta al saccheggio della città da parte delle legioni di Antonio (41 a.C.), quando agli abitanti fu sottratta gran parte della ricchezza. La naturale propensione di Palmira per l’indipendenza trovò il fautore di tale ambizione nell’imperatore Augusto che voleva stabilire relazioni non ostili coi Parti. Tra Roma e la Persia, Palmira venne a costituire un territorio neutro, attraverso il quale passava un rigoglioso traffico commerciale tra l’Oriente e l’Occidente. Le merci orientali, sia passando per la via di terra sia navigando il corso dell’Eufrate, giungevano a Palmira dove si formavano le carovane che, attraverso il deserto e scortate dalle milizie palmirene, si recavano ai grandi mercati di Emesa e Damasco. La gigantesca via carovaniera andò a sostituire quella che passava da Petra, contribuendo alla decadenza dei Nabatei. Accadde quindi che gli abitanti arabi di Palmira giunsero a un grado di civiltà molto superiore a quello dei beduini, dai quali dovevano proteggere i loro commerci. Il florido periodo di pace durato tutto il I secolo d.C., fu favorevole alla ricchezza di Palmira, e se la guerra partica di Traiano sembrò guastare il clima, la politica di Adriano ridiede vigore e sicurezza ai commerci; visitata dall’imperatore nel 129, la città assunse l’epiteto di Hadriana. Nel II secolo la prosperità di Palmira aumentò ancora e le sue società commerciali e bancarie istituirono filiali in tutto l’Oriente ma anche in Occidente, fino a Roma, in Pannonia, in Gallia, in Spagna. Provati dalla lunghe battaglie contro i predoni del deserto, gli arcieri di Palmira si arruolarono nell’esercito romano, costituendo uno dei validi elementi della sua cavalleria. Roma durante l’impero di Settimio Severo e successori, fece di Palmira il centro della sua azione contro i Parti, il cui potere stava tramontando. Se da un lato questa politica finì per nuocere ai commerci della città, dall’altro accrebbe l’importanza politica e l’autonomia di Palmira. Ci fu persino una famiglia patrizia che portava il nome romano di Iulii Aurelii Septimii e che assunse un grande potere. Odenato, rampollo della famiglia, con un vincente intervento militare a favore di Roma, ricevette in premio importanti titoli: divenne il “re dei re” e la sua autorità si estese a tutta la Siria e all’Oriente romano. Caduto vittima di una congiura assieme al suo primogenito, gli succedette un altro figlio ancora fanciullo, sotto la tutela della madre, la mitica Zenobia. L’energica regina portò alla rottura tra Palmira e Roma: l’imperatore Claudio impegnato nella guerra contro i Goti non riuscì a mantenere il potere in Oriente. Approfittando del momento Zenobia estese il suo dominio all’Egitto e a gran parte dell’Asia Minore, costituendo al giovane figlio Vaballato un immenso impero. Il successore di Claudio, Aureliano, inflisse ai ribelli palmireni una disfatta decisiva presso Emesa, catturò Zenobia e mise fine all’effimero impero. Iniziò così il declino di Palmira che vide la cessazione completa del commercio carovaniero a causa della situazione di guerra nella regione. Seguirono secoli di oblio, di dominazioni arabe e di saccheggi. Furono abbattute le mura e, della florida regina nata nel deserto all’ombra dei palmeti, rimasero i resti dei colonnati, dei templi e di quell’atmosfera delle rovine del passato che mettono malinconia o pace. Oggi i resti del sito archeologico sono stati danneggiati dalla furia cieca e ignorante delle generazioni fanatiche del ventunesimo secolo, e secondo gli esperti molto ci vorrà – in termini di impegno economico e umano – per far rivivere la bellezza di Palmira. Non ci si deve arrendere, per nessun motivo, alla tentazione di dimenticare questa magnificenza in mezzo alle dune, così barbaramente sfregiata. Palmira deve risorgere, a ogni costo, affinché chiunque possa un giorno ritornarvi per godere della maestosa bellezza dei suoi crepuscoli.
Il sapone di Aleppo (Trieste, 18/02/2016)
Nella martoriata Siria la città storica di Aleppo, patrimonio dell’UNESCO, diventa il simbolo della follia e della crudeltà, di un accanimento feroce e distruttivo non solo nei confronti delle popolazioni stremate ma anche dell’immensa ricchezza storica ridotta in frantumi. Il suq della cittadella (l’antico cuore storico) vendeva profumi e spezie, oggetti di ogni tipo, gioielli in oro e argento, vendeva in particolare il famoso “sapone di Aleppo” che nacque proprio in questa città. Un’autentica leggenda, un mito noto in ogni angolo della terra, il più famoso sapone del mondo che si produce ancora con metodi artigianali tramandati di generazione in generazione, da secoli. La sua produzione, diffusasi da Aleppo in tutto il Medio Oriente, prevede l’utilizzo di ingredienti semplici: olio di oliva e alloro. Il prodotto si prepara con l’aggiunta di soda caustica, lo si cuoce lentamente in un calderone di pietra, utilizzando lo stesso sistema di saponificazione usato in antichità. Terminata la cottura, durante il raffreddamento, si aggiunge l’olio d’alloro che profuma e arricchisce il sapone. La sua qualità dipenderà dalla quantità di olio d’alloro utilizzato, che può essere molto concentrato. I magnifici saponi di colore verde vengono messi in impalcature a forma di torre, dove si fanno maturare all’aria fresca per non meno di un anno. In questo periodo di maturazione il sapone inizia a cambiare colore, dal verde muta in un suggestivo colore dorato. Le antiche saponerie sorsero in zone ricche di piantagioni di alloro e ulivo, dove la tecnica fu affinata. La prima testimonianza dell’esistenza del sapone risale al 2800 a.C. e proviene da scavi nella zona dell’antica Babilonia. Qui fu ritrovato un materiale simile al sapone conservato in cilindri d’argilla che recano incise delle ricette per la preparazione. Gli arabi, già nell’antichità, utilizzarono le materie prime necessarie per produrre il sapone che abbondavano nei loro territori, raffinando i prodotti e creando dei saponi molto fini e profumati. Successivamente all’800 d.C., sull’onda dell’espansione araba in Europa, il sapone si diffuse in tutto il bacino mediterraneo, raggiungendo la Spagna e la Sicilia. I primi saponifici d’Europa sorsero nel XII secolo in Castiglia (Spagna) e in Italia (Savona, Venezia), poi in Francia, dove nacque il Sapone di Marsiglia che deriva direttamente da quello di Aleppo. Fin dall’antichità questa meraviglia fu utilizzata nei bagni turchi d’Oriente come trattamento di bellezza prima del tradizionale massaggio e le donne dei tempi andati sapevano bene che applicando il sapone sul viso per qualche minuto si ottiene un effetto molto simile, se non migliore, di una maschera cosmetica. Oggi la città di Aleppo viene ripetutamente bombardata, il suq è distrutto, cumuli di macerie sostituiscono i luoghi d’aggregazione e l’abitato, ferito gravemente, è conteso dalle potenze in campo. Viene da pensare che nessuno oramai si occupi del leggendario sapone, della sua produzione rispettosa delle antiche conoscenze e metodi di preparazione. Stamani però il programma di Gerardo Greco, Agorà, in onda su Rai 3, ha trasmesso un servizio della giornalista Lucia Goracci proprio da Aleppo. Anche se i raid aerei continuano, la giornalista racconta una città che non vuole morire e non si arrende alla tragedia. Nel suo servizio si sentono le voci di Aleppo, quelle dei suoi impavidi artigiani che produco il sapone nelle cantine e nei sottoscala dei palazzi distrutti. Usano gli antichi metodi, pongono il timbro del prodotto autentico e lo sistemano ordinatamente nei rudimentali scaffali. Sono lontani i tempi in cui gli agenti di commercio di queste piccole ditte viaggiavano per il mondo in lungo e in largo, anche in Italia; però dal loro racconto emerge con forza il coraggio di rinascere dalle proprie macerie. Sulla prima pagina del mio sito campeggia una frase di Jünger: “Profondo è l’odio che l’animo volgare nutre contro la bellezza”. Un odio che si esplicita da millenni nei confronti di ciò che di meglio l’umanità riesce a produrre, un odio visibile in molte parti del mondo: Aleppo è una di queste. Se però gli artigiani di quella lontana città, la culla della civiltà umana, oppongono con la forza e l’abilità delle loro mani la bellezza alla brutalità, la speranza alla rassegnazione, allora qualche possibilità per tutti noi, in generale, esiste ancora. Il sapone di Aleppo dona tuttora bellezza alle donne, lo fa da migliaia di anni, e non scomparirà fagocitato dall’orrore.
Everyman (Trieste 09/02/2016)
Quando lessi anni fa Everyman di Philip Roth, rimasi sconvolta per la potenza narrativa, la brutalità della descrizione riferita all’impotenza dell’uomo davanti al decadimento, alla vecchiaia e alla morte. Sapevo che prima o poi, direttamente o indirettamente, ci avrei fatto i conti e ne avevo paura. Poi non ci pensai più, scacciai la riflessione dalla mia mente, come in un inutile atto teatrale, volendo nascondere la realtà dietro ad una finzione scenica. La vita però non è il teatro, non ci assomiglia neppure. Nulla si può cambiare o smantellare, lo sceneggiatore non può modificare il testo imposto dal regista universale. In questi ultimi mesi quella realtà è emersa con prepotenza nella mia vita, sconvolgendo tutti gli equilibri, ogni convinzione o sicurezza che con fatica ho appreso nella mia esistenza. Davanti al decadimento e alla malattia mi sono trovata senza forze, senza risorse, del tutto disorientata, spaventata e sola. Se la disfatta riguarda noi stessi forse l’affrontiamo meglio, con un maggiore senso di rassegnazione e disincanto, quando invece riguarda le persone care, l’impotenza intrinseca nell’essere umano si manifesta in tutta la sua disarmante crudezza. Così ad inizio anno, quasi in modo vigliacco, sono scappata in Istria, lontano dalla cosiddetta “civiltà”, durante l’unica nevicata che si è vista da quelle parti fino a qualche giorno fa.
A Stridone il tempo dell’uomo non passa mai, rimane come cristallizzato nello spazio e nel tempo universale, ogni cambiamento epocale lo sfiora appena e, nel corso dei decenni, i piccoli mutamenti amministrativi imposti dal “padrone” di turno hanno impattato poco sulla vita dei quattro cristi che lo abitano. Le case di pietra, costruite nei secoli, hanno di tanto in tanto intonaci nuovi, tetti che non perdono e serramenti che con fatica controllano le infiltrazioni umide; tutto sommato però la natura non fa alcuna fatica e infilarsi ovunque, con audacia e arroganza. I boschi, i campi e i prati circondano il borgo, lo stringono in un abbraccio verde che d’inverno muta le tonalità e ingrigisce la visuale. Qui ho passato diciassette anni della mia vita, in assoluta e dolorosa solitudine, ora invece vengo a rifugiarmi per un dolore nuovo e devastante che nella solitudine trova qualche accenno di consolazione. Il destino ha un amaro senso dell’umorismo. Camminare per ore nei prati incolti e nei boschi ingrigiti della mia infanzia, assume un significato catartico senza pari, una specie di morte e di rinascita a ogni passo lungo i sentieri impervi frequentati oramai solo dagli animali selvatici. Ed è così che ho incontrato il “dio dei boschi”, come è accaduto tante altre volte, mentre fuggiva dalla mia imperfezione e dal mio decadimento umano, saltando oltre le siepi, schivando i rovi, calpestando le foglie rinsecchite.
Questa volta ho voluto rubare la sua eleganza scattando qualche foto, imprigionando quella grazia, quella vitalità in un attimo che conserverò sempre. Invidio il “dio dei boschi”, la sua voglia di vivere, il rispetto per gli equilibri che lo mantengono su questa terra. Quel senso di libertà così distante dalla condizione umana, dalla morbosità di una specie che tutto vuole fagocitare e piegare al proprio volere. La morte è lì, in agguato, e il “dio dei boschi” lo sa. Il suo spirito vagherà ancora tra quei rovi, quegli alberi spogli, quei prati incolti, anche dopo la sua fine terrena. Noi umani invece? Noi che abbiamo inventato paradisi artificiali, siamo degni di una seconda possibilità? Ed ecco che la mia mente si ribella, rifugge dalla sofferenza, corre indietro nel tempo. Bastano pochi mesi, all’estate passata, quando ancora mi illudevo che tutto potesse essere diverso e meno distruttivo. Una vacanza, un breve viaggio nel Trentino che ho narrato in due libri appena usciti, alla ricerca dei luoghi e dei sapori raccontati. Castelli, posti nuovi e la quiete di un lago di alta montagna, in piena estate, nel caldo torrido di una stagione infuocata.
Poi la mente mi riporta a Stridone, sempre in quella torrida estate di qualche mese prima, quando tutto sembrava ancora avere un senso, una dimensione accettabile, ed i ricordi dell’infanzia erano condivisi e raccontati in una successione emotiva, non cronologica. La “vecchia signora”, la mia casa, bella dopo il restauro, bella come non lo è mai stata prima e quella pergola con l’uva nera, lucente al sole, curata da mio padre. Sul gelso, tra i rami verdi, una deliziosa gattina grigia che papà ha salvato e che ogni tanto accarezza con le sue mani nodose, segnate dalla fatica. Ora è qui la gattina, accanto a me, mentre scrivo. Dorme serena sulla poltroncina del soggiorno, tra due librerie, sotto lo sguardo severo del busto di Dante Alighieri. A me sembra tutto lontano, sbiadito, svanito e il dolore diventa insopportabile.
Se per Roth ogni uomo deve affrontare il demone della morte prima o poi (è inevitabile che accada e che ci colga impreparati), allora perché ci preoccupiamo tanto dell’inferno dopo la morte? Lo viviamo mentre siamo in vita, in tutte le sue sfumature. Il dolore insegna tanto, a tutti, insegna soprattutto una cosa: a sopportarlo. Non ci sono altre vie di fuga.
L’Italia di “Pane e amore…” (Trieste, 23/12/2015)
Il 22 dicembre di sessant’anni fa usciva nelle sale italiane il delizioso film di Dino Risi, Pane, amore e…, che consacrò in patria e fece conoscere all’estero la meravigliosa Sophia Loren. Terzo capitolo della fortunata serie di film popolari, poetici e straordinariamente ben scritti che raccontavano un’Italia povera e malinconica, piena di speranze e prospettive per il futuro. Un Paese proiettato verso un cammino di riscatto e di ambizione da soddisfare, a tratti ancora ingenuo, promettente come una giovane fanciulla in un chiaro di luna di primavera. Esattamente come lo erano le sue protagoniste, dapprima l’esuberante, bellissima e talentuosa Gina Lollobrigida, poi la sua storica “rivale”, Sophia Loren appunto, che incantò con la prorompente mediterranea bellezza il pubblico e la critica. Un mondo che sembra perduto e sepolto nella precarietà dei giorni nostri, nel cinismo e nella fame che non è più di pane ma che devasta di più le persone, le famiglie e le comunità. Amo questo film da sempre, da quand’ero piccola, e mentre scrivo questo pezzo le sue scene colorate e vitali scorrono sullo schermo del televisore. La tecnologia moderna mi consente di vederlo tutte le volte che voglio, il che forse gli toglie un po’ di magia, però il suo forte messaggio di speranza per un futuro migliore, fatto di cose semplici da apprezzare con gusto (l’amore, il cibo, la compagnia) di certo non si perde. Anni fa scrissi un libro, Focolare Mitteleuropeo, dove raccontavo le ricette tipiche della mia famiglia e della regione, associando i sapori delle pietanze ai ricordi di una vita. Così descrivendo come si faceva a casa mia il risotto con le vongole, evocai il film ambientato a Sorrento, dove la “pescivendola” Loren faceva impazzire il “maresciallo” Vittorio De Sica.
[…] Immaginavo di essere a Napoli, oppure di fare una passeggiata a Sorrento, mentre una meravigliosa e giovane Sophia Loren faceva girare la testa a tutti col suo incandescente vestito rosso in Pane, amore e… Il profumo delle vongole aveva il potere di avvicinarmi al sogno che ho sempre identificato col cinema.
Ricordare il sogno, associarlo al sapore o all’odore di un’infanzia perduta per sempre, non è solo malinconia ma anche il tentativo di vedere la realtà attraverso quegli occhi pieni di curiosità e privi di ogni malvagità o cinismo, per poter immaginare un futuro dove la semplicità e la gioia non siano solamente attimi privi di senso ma progettualità concreta e quotidiana.
La Pulzella alla Scala (Trieste, 09/12/2015)
Mancava da 150 anni al teatro più famoso del mondo – la Scala di Milano – una delle opere meno conosciute di Giuseppe Verdi: la Giovanna d’Arco. Uno spettacolo che ha raccolto il bel mondo e il jet set nel maestoso teatro milanese, tra controlli ferrei, polizia in borghese mescolata al pubblico e cecchini appostati ovunque. Scelta quanto mai aderente ai temi contemporanei, che tormentano il mondo occidentale, quella di rappresentare la Pulzella di Francia, la massima eroina della Guerra dei Cent’anni, il simbolo storico e “plastico” del popolo francese ferito dentro casa. Il tempio della lirica si è colorato, come al solito, di abiti d’alta moda, di dame ingioiellate, di politici in pompa magna e di starlette dello spettacolo, più interessate ad esibire scollature vertiginose che appassionarsi al bel canto. Diretta dal Maestro Riccardo Chailly, interpretata da Anna Netrebko e Francesco Meli (l’artista russa, apprezzatissima, è stata omaggiata persino dal lancio di fiori), per la regia di Moshe Leiser e Patrice Caurier. I registi hanno scelto un taglio dove prevalgono i contenuti psicologici della protagonista, ossia quelli di una giovane mistica, ossessionata dalla visione di angeli e demoni, che fa della croce la via di salvezza sua e dell’intero Regno. L’opera è stata applaudita per dieci minuti; gli spettatori hanno apprezzato gli interpreti, il Maestro, l’allestimento, meno apprezzata forse la regia. La Pulzella appariva sacrificata sull’altare della psicanalisi che tutto scompone, seziona e analizza, dipinge di “patologico” il trasporto religioso, la verginità e la riscossa di una contadina esasperata da una guerra infinita. Viene da chiedersi perché in ogni rappresentazione artistica occidentale occorre dissacrare i personaggi ed i concetti del nostro mondo, specialmente se hanno a che fare con la religiosità e la spiritualità. Ogni artista è libero di rappresentare le sue visioni e le sue interpretazioni, ma in questo caso (come in tanti altri) personalmente non ho visto coraggio, bensì facile e “sicura” provocazione. Un esempio calzante di provocazione a sfondo religioso coraggiosa? Le vignette di Charlie Hebdo, equamente blasfeme e irriverenti nei confronti di tutte le religioni. Attendo una rappresentazione delle Mille e una notte (teatrale, televisiva o cinematografica) dissacrante per la cultura araba e musulmana, oppure un testo di Rushdie, Houellebecq, Ayaan Hirsi Ali (per aver realizzato un corto tratto da un libro di questa scrittrice Teo van Gogh perse la vita), solo dopo si potrà parlare di coraggio artistico non condizionato dalla paura.
Forse che sì forse che no (Trieste, 23/11/2015)
Inizio citando un romanzo di Gabriele D’Annunzio, Forse che sì forse che no, titolo che lo scrittore mutuò dal motto dei signori di Mantova, i Gonzaga, col quale Vincenzo I (1562-1612) tramandò alla storia la sua vita amorosa e l’incerta fortuna delle sue campagne guerresche contro i Turchi. Un’incertezza, una incapacità cronica di prendere delle decisioni, che pare accompagnare la storia della penisola e di tutta Europa, anche oggi, anche dopo una dichiarazione di guerra e di terrore inequivocabilmente esplicita. Ciò che colpisce maggiormente – oltre alla consapevolezza che questo Continente fece finta di non vedere e non udire neppure i proclami nazisti di molti decenni fa – appare il cambiamento di atteggiamento, talmente radicale da sembrare schizofrenico, nei confronti dei Servizi Segreti, e questo in Italia più che altrove. Da più di una settimana in tutti i programmi televisivi, in ogni telegiornale, sulla carta stampata e on line, ogni politico e ogni analista, ogni giornalista e ogni esperto di geopolitica, ogni interventista e ogni pacifista, insistono con veemenza nel dire che il lavoro di prevenzione e contrasto della minaccia concreta che incombe su ognuno di noi, in qualsiasi momento e circostanza, in ogni possibile luogo di aggregazione, dev’essere condotto dai Servizi. Da organo dello Stato in bilico tra legale e illegale (nella migliore delle ipotesi), alla propensione per la “devianza”, la manipolazione e l’azione fuori controllo nell’inquietante zona grigia dove nulla appare chiaro, a salvatori delle libertà e della sopravvivenza della nostra incrinata civiltà. Questo a poche settimane dallo scandalo dei riscatti pagati per liberare gli ostaggi italiani che hanno riempito le pagine dei giornali e hanno gettato vagonate di fango su chi ha agito in tal senso. Lascia infatti perplessi il repentino cambiamento di atteggiamento, dettato evidentemente dalla paura che chi agisce in quella zona grigia dove tutto è fosco, magari si sia stancato di disattivare le possibili micce che rischiano di far esplodere la polveriera sulla quale siamo tutti seduti. Tutto appare ancora più curioso, per non dire quasi grottesco, se pensiamo all’atteggiamento che la Magistratura e certa politica italiana hanno condotto negli anni, ovvero una sapiente e feroce campagna denigratoria nei confronti di questi ambienti, sbattendone i vertici nel tritacarne mediatico e nelle aule dei tribunali, sino a riformare i Servizi fino alle viscere, forse snaturandone il senso stesso. Ed è ciò che sostiene il generale Mori, ex capo del Sisde, in un’intervista rilasciata al quotidiano il Foglio:
“In Italia la parola ‘servizi’ viene sempre affiancata a quella ‘deviati’. Descritti da un pregiudizio non sempre ingiustificato, ma largamente abusato, come qualcosa di tetro, opaco, poco lineare, e trattati come materia di contesa politica, faziosa e irresponsabile, da una legislazione contraddittoria e continuamente sottoposta agli spasmi dell’opinione pubblica, i servizi nel nostro paese sono stati devastati” […] Però poi si pretende che siano pronti, efficienti, capaci di prevenire – dio non voglia – anche atti di terrorismo”. (Intervista di Salvatore Merlo, 18/11/2015 – il Foglio)
Ora, io sono cresciuta in una dittatura dove la legge non ha mai contrastato il lavoro di controllo di tali organismi, anzi lo ha in ogni modo favorito. Nei paesi comunisti non c’era nulla di troppo segreto in questa azione, si agiva a viso scoperto e si poteva contare su una vasta rete di delatori che informavano anche del battito d’ali di una rondine. La finalità poi non era proteggere il cittadino, ma aggredirlo qualora non fosse stato allineato. Quindi, per ovvi motivi, lontane sono da me le simpatie verso un certo modo di agire poco ortodosso e irrispettoso dei diritti tanto sbandierati in Occidente; rimane comunque il fatto che si passa da un estremo all’altro con tale faciloneria e colpevole pressapochismo, che pare di stare su una girandola impazzita e fuori controllo. Per cui mi chiedo quanto ancora ci metteremo a stabilire che l’antico motto dei Gonzaga, così abilmente usato dal D’Annunzio nel suo romanzo, finirà per condurci alla catastrofe? Se vogliamo davvero sopravvivere, se desideriamo che la nostra civiltà non finisca come quella romana che si spaccò e smembrò in modo cruento, consegnando il Continente a secoli di incertezza e brutali scorrerie barbariche, dobbiamo fare una seria riflessione sulla pericolosità dell’immobilismo, del compromesso economico e della condanna di chi difende la libertà con metodi poco ortodossi.
La volutamente incompresa Oriana Fallaci (Trieste, 17/11/2015)
“Chi ama la vita è sempre col fucile alla finestra per difendere la vita.” Oriana Fallaci (citazione suggeritami da Alberto Piccini)
Con molta enfasi la rete ha diffuso una lettera aperta pubblicata da l’Espresso, dedicata ai “fan” di Oriana Fallaci. L’autore della lettera accusa i lettori della scrittrice di non aver “vissuto” gli ultimi anni, anni nei quali l’Occidente è intervenuto militarmente in diversi paesi, quali l’Iraq, per reagire al cosiddetto “scontro di civiltà” con l’aggressione diretta. In tutto ciò la Fallaci viene descritta come la massima “ispiratrice”, la musa della guerra, la Cassandra delle ecatombi. Chiunque abbia letto l’Oriana sa che l’accusa non è vera: lei predicava la difesa dei valori del mondo occidentale, criticava il multiculturalismo e sosteneva che occorre difendersi quando si viene attaccati, ma non di certo attaccando paesi a caso e senza avere un’idea chiara del luogo dove si interviene. Ecco un estratto dal libro “Oriana Fallaci intervista Oriana Fallaci” del 2004:
“E sull’Iraq che cosa mi dice?
Le dico ciò che ho detto ne La Forza della Ragione e prima ancora nell’articolo che la vigilia della guerra pubblicai sul Wall Street Journal per esprimere i miei dubbi sull’opportunità di farla […] E come scrissi in quell’articolo, ci ritroveremo con una Repubblica Islamica dell’Iraq. Cioè con un paese nel quale i mullah e gli imam impongono il burkah, lapidano le donne che vanno dal parrucchiere, impiccano la gente allo stadio, e insomma nuotano dentro oceani di sangue. Allora tanto valeva tenersi Saddam Hussein.” (pg. 90-91)
Non ci sono dubbi che Oriana Fallaci era una profeta, aveva previsto la nascita dell’Isis con dieci anni di anticipo. Ora due sono le considerazioni da fare sull’autore dell’articolo: la prima è che non ha mai letto un libro della Fallaci e quindi parla senza conoscere (come fanno in troppi ahimè), oppure mente e mistifica sapendo di farlo. Non saprei dire cosa sia peggio.